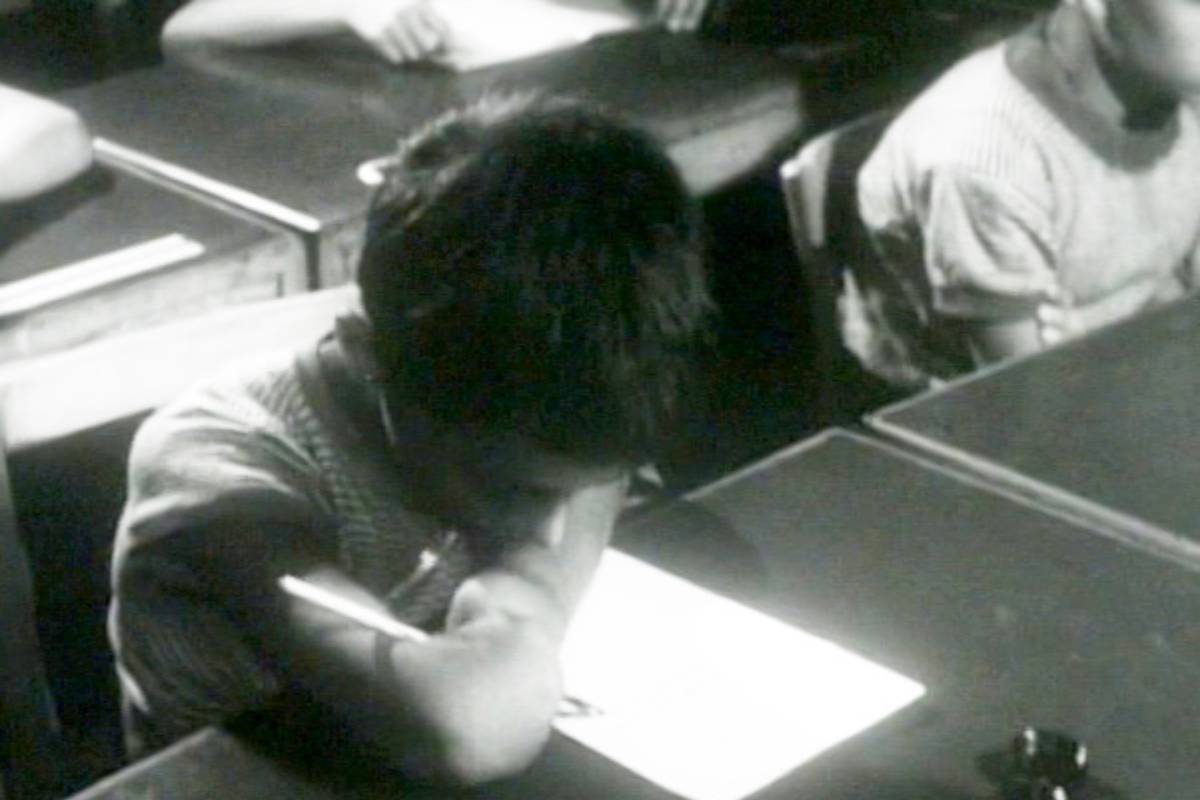Cristina Cattaneo, responsabile della ricognizione dei resti di Ambrogio, Gervaso e Protaso al centro del convegno in Basilica, ne illustra il significato e le caratteristiche. E parla anche del lavoro che conduce, come medico legale, per dare un nome alle vittime dei “viaggi della speranza”
di Luisa
Bove

Al convegno che si terrà venerdì 30 novembre nella Basilica di Sant’Ambrogio sarà Cristina Cattaneo, medico legale e professore ordinario alla Statale di Milano, a illustrare gli aspetti scientifici della ricognizione recentemente condotta sulle reliquie di Ambrogio, Gervaso e Protaso: è lei, infatti, che ha diretto gli studi sui resti del Santo patrono e dei due martiri. Un lavoro insolito, ma che incuriosisce.
In che cosa consiste il suo lavoro?
Per gran parte nello studio dei resti umani, sia recenti (quindi di persone morte pochi giorni fa) o antichi: è la stessa disciplina applicata a periodi diversi. Il nostro istituto comprende tanti piccoli laboratori, per cui seguiamo il morto di ieri come i teschi scheletrici di 2000 anni fa. Facciamo anche l’esame sui vivi, per cui visitiamo ed esaminiamo bambini maltrattati o richiedenti asilo vittime di tortura per cogliere i segni di violenza.
Che cosa l’ha stupita di più della ricognizione dei resti di Ambrogio, Gervaso e Protaso?
I due fratelli. Ora mi sento di chiamare così Gervaso e Protaso. Per Sant’Ambrogio mi aspettavo già di trovare il volto asimmetrico, raffigurato anche dal mosaico, e la frattura alla clavicola. Per i due fratelli, invece, ci sono poche fonti, anche se ora ci dobbiamo confrontare molto con gli storici. Gervaso e Protaso erano due ragazzi, alti più di un metro e ottanta, ma quello che mi ha sorpreso è la somiglianza tra loro: è difficilissimo distinguere le ossa dell’uno da quelle dell’altro, perché ci sono pochissimi millimetri di differenza. Siccome le ossa sono come le impronte digitali, questo indica una grande vicinanza tra i due.
Ma allora non potrebbero essere gemelli?
Sul fatto che fossero gemelli non posso esprimere certezze, perché alcuni aspetti li distinguono: per esempio, uno ha un cranio più grande, l’altro leggermente più piccolo; inoltre hanno disegni del tessuto osseo (osservati in radiografia) simili, ma un po’ differenti. Quindi per ora non mi spingerei ad affermare che erano gemelli. Hanno anche gli stessi difetti congeniti, come quello a livello cervicale: entrambi hanno una strettoia del tessuto osseo dove passano vasi che vanno al cervello. Infine su uno dei due ho trovato i segni della decapitazione, avvenuta in modo classico, con la testa sul ceppo, perché il taglio è molto basso.
Per lei cosa ha significato lavorare su questi Santi?
Io non sono milanese, ma vivo a Milano da tantissimo tempo e fin da giovane, quando andavo a visitare la cripta nella Nasilica di Sant’Ambrogio, ho sempre pensato: «Che bello sarebbe studiare questi scheletri!». Oltre a essere persone con uno spessore spirituale, sono affascinanti per lo spessore storico: Sant’Ambrogio è il personaggio più importante dell’epoca.
Lei si occupa anche delle vittime delle migrazioni nel Mediterraneo…
Questo lavoro riguarda i diritti umani. Da quindici anni, di fronte ai disastri di massa dei migranti nel Mediterraneo, nessuno si dà da fare per identificare le vittime: né l’Europa, né i Paesi di origine. Quando cade un aereo tutti corrono a identificare i morti, non solo per rispetto dei defunti, ma soprattutto per i vivi: i parenti devono sapere se il figlio o la madre sono morti, non solo per motivi amministrativi, ma per una questione di salute mentale. Ormai è stato provato che rimanere nel limbo, perché non si sa se una persona è morta (si parla di «perdita ambigua»), e non potere elaborare il lutto, rischia di provocare patologie psichiatriche o psicologiche.
E quindi voi cosa fate?
Siamo il braccio tecnico dell’Ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse: da quattro anni ci occupiamo dei maggiori disastri per cercare di identificare le vittime. Questo implica raccogliere i dati dei morti e cercare di mettersi in contatto con i loro parenti che vivono nei Paesi di origine (Mali, Eritrea…) o di destinazione (Europa, America…), oppure sono in transito. Per il disastro del 3 ottobre 2013 con 400 morti, per esempio, abbiamo collaborato con la Marina e 12 altre università: siamo riusciti a contattare 70 famiglie e ciò ha permesso di identificare oltre la metà delle persone che i parenti cercavano. Abbiamo affrontato anche il disastro del famoso barcone naufragato il 18 aprile 2015 con mille vittime, soprattutto di origine subsahariana: abbiamo eseguito tutte le autopsie e ora, anche grazie alla Croce Rossa internazionale, stiamo cercando di raccogliere i dati dei familiari nei Paesi di origine e in Europa. Poi c’è la questione degli orfani, lasciati presso amici nei campi di transizione: hanno bisogno del certificato di morte dei genitori, altrimenti non possono ricongiungersi con parenti che abitano in altri Paesi.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie