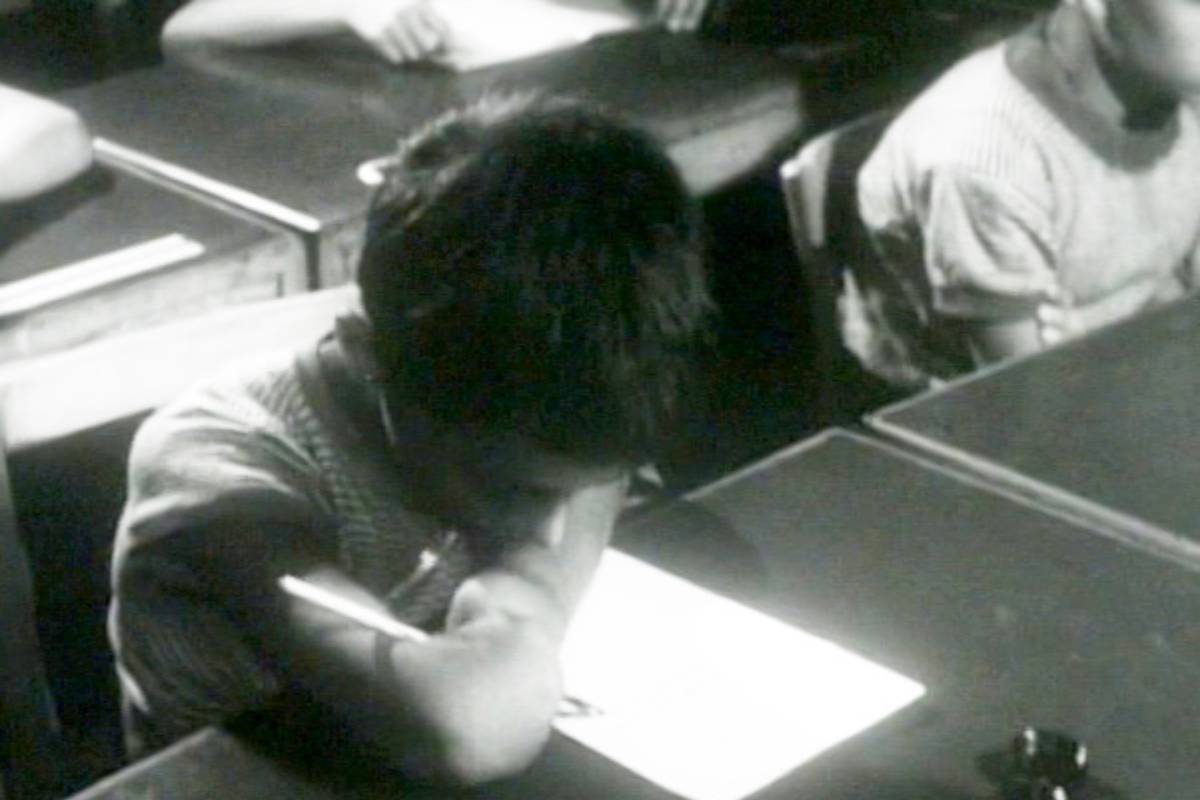La lunga storia della prima fondazione lombarda dei bianchi monaci di Citeaux.
di Luca FRIGERIO

«Morimondo», morire al mondo. Volgevano le spalle al secolo, i cistercensi che nel 1134 giunsero nella valle del Ticino, vicino ad Abbiategrasso. E tuttavia proprio dal secolo provenivano, giovani, forti, ricchi di entusiasmo. Cavalieri alcuni, nobili altri, uomini cresciuti nei palazzi, educati nelle università, che avevano conosciuto i piaceri della vita, e che ciò nonostante avevano deciso di abbandonare tutto, vestire un abito di lana grezza e seguire il Signore.
Morire al mondo. Un desiderio grande di spiritualità, una vocazione all’ascesi, un’ideale di perfezione da raggiungere attraverso il silenzio e la meditazione. Eppure questo mondo andava vissuto fino in fondo, i monaci cistercensi lo sapevano bene. Un mondo forse pieno di errori, di brutture, di egoismi: ma un mondo da cambiare, non da rifiutare. Secondo l’esempio stesso di Cristo, che per salvare gli uomini si era fatto uomo.
Erano tredici i cistercensi che dalla casa madre francese arrivarono quaggiù, dodici monaci guidati da un priore. I primi dell’ordine di Citeaux a insediarsi in terra lombarda. E non persero neppure un giorno. Subito cominciarono a lavorare la terra, a zappare, a falciare. E a pregare. Come tutti i rivoluzionari autentici, infatti, anche i cistercensi non vollero inventare nulla, ma ritornare piuttosto alla purezza, all’essenzialità delle origini: l’Ora et labora del padre Benedetto, questo e nient’altro.
Roberto di Molesmes, il fondatore di Citeaux, li aveva messi in guardia; Bernardo, il più energico fra i discepoli del nuovo ordine, l’aveva loro ribadito: è la superbia il peccato più grande, la vera tentazione del Maligno. Basta con le vesti principesche, basta con gli ori e le gemme, basta con l’orgoglio che spinge gli uomini di Chiesa a sentirsi più potenti di re e principi… Gli amici di Gesù erano dei poveri: il vero monaco deve vivere come loro. Berrà vino, ma un vino semplice. Mangerà pane, ma i tozzi neri e ruvidi con cui si sfama la povera gente. E per guadagnarsi quel pane lavorerà con le proprie mani, per non dipendere da nessuno, per non pesare sui fedeli, per essere servitore e non servito.
Con il passare del tempo, quest’ansia di rinnovamento e di fedeltà al Vangelo sarà duramente messa alla prova. Ma nella prima metà del XII secolo, negli anni colmi d’entusiasmo in cui andava nascendo questa nuova comunità, la croce e l’aratro erano davvero gli strumenti quotidianamente nelle mani dei cistercensi di Morimondo. Il territorio attorno cambiava aspetto, con le bonifiche, con i campi sottratti alla sterile boscaglia e coltivati. E con il mutare dell’ambiente, anche gli uomini trovavano una nuova fiducia: là dove era il buio delle tenebre, ora brillava una luce di speranza.
Non fu la grande chiesa che ancor oggi ammiriamo, il primo edificio della neonata abbazia. E la cosa non deve sorprendere. Innanzitutto vennero costruiti i laboratori, i depositi dove raccogliere gli attrezzi agricoli e le fienagioni, la fornace dove cuocere i mattoni, la fucina dove forgiare il metallo. E contemporaneamente si edificarono i luoghi in cui i monaci avrebbero trovato riparo. Una semplice cappella, per il momento, sarebbe bastata al piccolo gruppo di religiosi.
Anche l’arte cistercense, insomma, incominciava dal lavoro, dalla sistemazione degli appezzamenti, dalla definizione dei confini. Iniziava cioè con il creare la radura, perché respingere ciò che è oscuro, riportare all’ordine ciò che è informe o confuso, è anche far trionfare l’armonia, restaurare la primitiva bellezza. Il resto verrà da sé, spontaneamente, naturalmente.
Era stato assai duro, san Bernardo, con le inutili ostentazioni di lusso nelle chiese, con quelle decorazioni esuberanti che volevano stupire, più che aiutare a riflettere. E ciò nonostante, il monaco di Clairvaux non era un iconoclasta. Per lui, per tutta la sensibilità cistercense delle origini, l’arte aveva una funzione importantissima, fondamentale: far sorgere lo spirito cieco verso la luce, risuscitarlo dalla sua sommersione interiore. L’arte è strumento di rivelazione, di rinascita, di una conversione che, come l’atto del Creatore, non è concluso nell’istante di un avvenimento puntuale, ma fluisce nella durata ininterrotta di un destino.
Il complesso di Morimondo non farà eccezione. La sua chiesa, dedicata a Maria come tutte quelle dell’ordine di Citeaux, appare come una summa del pensiero teologico bernardiano: ampia, spaziosa, retta su forti pilastri, anelante al cielo. E tuttavia semplice, essenziale, dove l’equilibrio stesso diventa bellezza, e dove perfino le irregolarità sono memento al monaco del suo faticoso cammino verso la perfezione cristiana. Via le pietre pregiate, via i marmi, via gli stucchi ridondanti: tutto è fatto con i rossi mattoni padani, segno di un radicamento totale al territorio, di un’umiltà tradotta infine in altissima dignità.
La costruzione del tempio, avviata attorno al 1180, proseguirà per oltre un secolo, giovandosi delle esperienze fatte nella vicina Chiaravalle e in altri cantieri lombardi, e determinando così, quaggiù, un’architettura più matura e completa, gotica nella forma, monastica – secondo la declinazione cistercense – nell’essenza. Ma non mancarono le difficoltà, le battute di arresto, le controversie.
Morimondo crebbe rapidamente, forse persino troppo rapidamente. Nel giro di pochi anni aveva generato due filiazioni, Acquafredda nel comasco e Casalvolone nel novarese, mentre il numero dei suoi monaci andava sempre più aumentando. Nello scriptoriumlavoravano alcuni tra i più abili copisti e miniaturisti dell’epoca, producendo volumi ricercati in tutta Europa. Acquisizioni e donazioni ne avevano esteso i possedimenti, portando maggiori ricchezze, ma anche nuovi problemi. E liti, gelosie e contese finirono per abbattersi sul grande centro monastico, inevitabilmente coinvolto nelle lotte che sconvolsero i comuni lombardi tra il XII e il XIII secolo.
L’abbazia ticinese ebbe Federico Barbarossa per amico, il che non le giovò certo nei rapporti con Milano. Federico II, più tardi, le negò quella protezione che pur le aveva assicurato, lasciandola in balia di saccheggi e distruzioni. Nel Quattrocento finì in commenda, ma riuscì a riprendersi grazie all’innesto di cistercensi fiorentini. San Carlo Borromeo più tardi le affidò nuovi compiti pastorali, quale parrocchia dei centri rurali attorno. Ma dalla fine del Settecento, con le soppressioni napoleoniche, Morimondo vide disperdersi l’intero suo patrimonio, i suoi ambienti trasformarsi in cascine e casa coloniche, deperendo, stravolgendosi, giorno dopo giorno.
Il disinteresse e l’abbandono sono durati a lungo. Ma da diversi anni ormai, per le antiche sale, all’ombra del chiostro, nuove forze hanno riannodato con passione i fili di una lunga storia, promuovendo restauri e iniziative, una fondazione e un museo. E l’abbazia di Morimondo è davvero rinata.






 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie