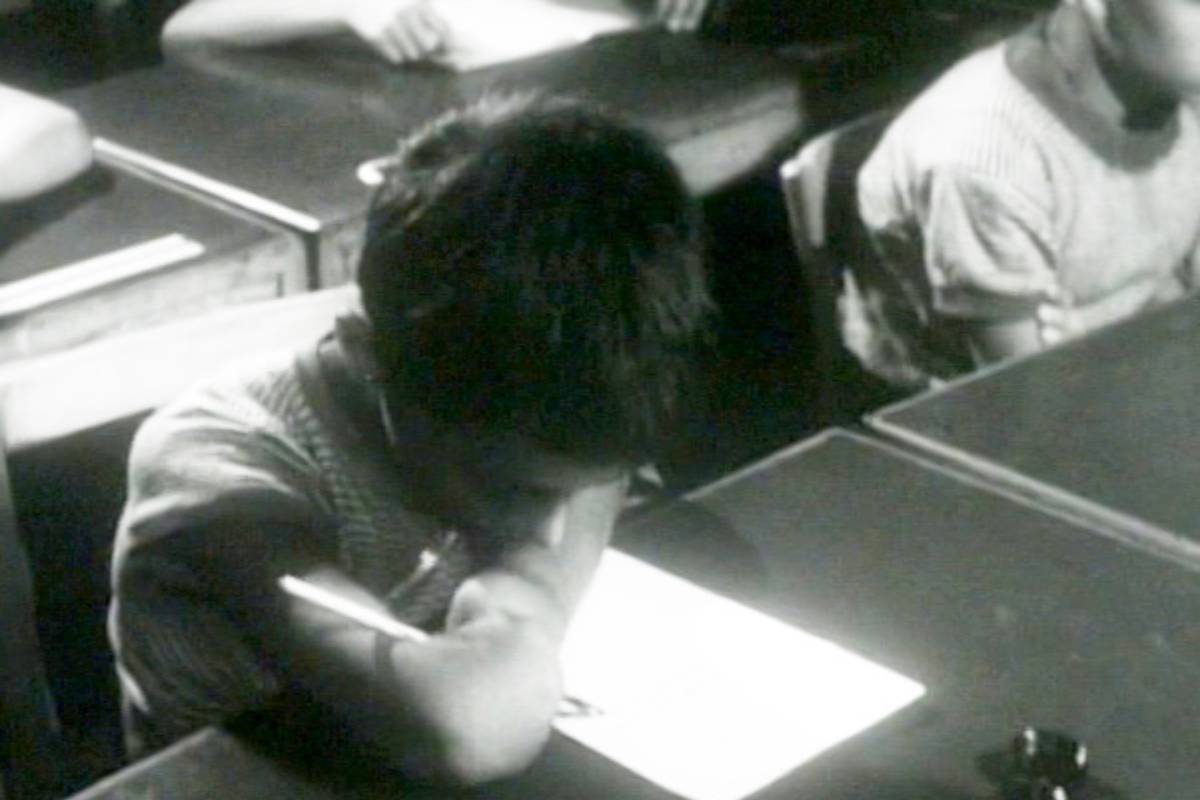Riemergonodall’obliotoccantipaginedi chi ha vissutoin prima personail drammadell’ultimo conflittomondiale. Il diario di Pino Giavazzi, ufficiale della Regia Marina fra il 1941 e il 1943.

«Quando ho iniziato a leggere il diario di guerra del mio prozio, Giuseppe Giavazzi, una raccolta di memorie sulle vicende belliche della Regia Marina, non sapevo a cosa sarei andata incontro». Ilaria De Bartolomeis, pronipote di Pino Giavazzi, comincia così la presentazione del diario di guerra dello zio, coinvolgendo i lettori, fin dalla prima pagina, nel viaggio che l’ha portata a scoprire, man mano sfogliava le pagine, un vissuto di umanità vera, sensibile e forte.
Il diario di Pino Giavazzi, curato da Antonio De Bartolomeis e Francesco Giavazzi, rimasto sconosciuto ai familiari fino alla morte del protagonista, non è una semplice cronaca notarile e impersonale o la registrazione giornaliera e puntuale degli accadimenti militari, ma è – scrive Ilaria De Bartolomeis – «un diario intimo in cui traspaiono i valori e i tormenti, il coraggio e le paure, le speranze e le fatiche di un giovane ufficiale che, senza dover necessariamente assecondare quella politica prepotente e militarista che allora infuocava molti animi, con il suo impegno e senso del dovere ha partecipato attivamente a una pagina di storia del nostro Paese».
In queste pagine proponiamo ai lettori alcuni passi del diario che ha destato nei familiari e nelle persone che hanno conosciuto e stimato il dott. Pino Giavazzi grande stupore e intensa commozione.
Settembre 1940 – Marzo 1941,
sulla nave ospedale Po
«Dopo cinque giorni che ero imbarcato: partimmo per Messina dove il 26 ottobre 1940 salpammo diretti a Valona. Iniziano così i viaggi: Valona-Bari, Durazzo-Bari, Bari-Bengasi-Tripoli.
Con grande sorpresa scopro che il cappellano di bordo è monsignor Sergio Pignedoli che avevo conosciuto all’Università cattolica dove era assistente spirituale. La missione del 14 marzo 1941 per Valona è stata fatale. Partiti da Bari alle ore 10.30, con a bordo la contessa Ciano, si arriva alle 20 e si dà fondo al solito porto. Nave spenta perché zona militare. Dopo cena mentre tutti se ne vanno a dormire, io con altri tre ufficiali giochiamo a bridge. All’improvviso un colpo fortissimo scuote la nave, le luci si spengono e i vetri vanno in pezzi.
La nave affonda. Usciamo di corsa dal quadrato ufficiali e io faccio in tempo a vedere un aereo che si allontana e una scia veloce passare di prora. Un idrosilurante ha sganciato un siluro che ci ha colpiti a poppa. Subito ci dividiamo per correre nei vari locali e dare l’allarme al grido: “si salvi chi può”. Mentre il personale si getta in mare noi quattro saliamo sul ponte delle barche per cercare di ammainarle.
Riusciamo a metterne in mare una, poi la nave sbanda paurosamente sulla sinistra. Il secondo ufficiale ci dice di correre a prora, sul ponte di comando, pronti a buttarci a mare al suo ordine. Con noi c’è anche un marinaio.
Il comandante in seconda guarda la catena di dritta e ci dice: “se tiene forse ci salviamo, se no ci capovolgiamo con la nave”. A poppa la nafta si incendia. Guardiamo tutti la catena dell’ancora che sarà la sola nostra salvezza. La catena cigola ma resiste. La nave si raddrizza e il comandante ci dice d’esser pronti per buttarci a mare in piedi.
Con le mani sulla testa ci sporgiamo sul fuori bordo senza calcolare l’altezza che ci separa dall’acqua, e poi al grido “a mare”, ci buttiamo. La nave intanto aveva iniziato la discesa veloce verso gli abissi.
Toccato il mare, mi inabisso per alcuni metri a causa del mio peso e dell’altezza da cui mi ero lanciato. Mentre sto emergendo per respirare, sento un gran colpo alla spalla destra e ritorno sotto bevendo. In questo momento ho avuto la netta sensazione che per me tutto era finito.
Il marinaio che mi era vicino si era buttato alcuni secondi dopo e mi aveva colpito in pieno con il suo corpo. Però si è accorto e non vedendomi ha iniziato a cercarmi. Vista la mia testa emergere appena sull’acqua, la prese per i capelli e la portò al largo. Quella testa poteva essere la mia, come infatti era, come quella di un’altra persona. Rinvenuto che fui dal colpo, dall’acqua e dalla nafta bevuta, mi trovai sostenuto dal marinaio che mi teneva la testa sulle sue spalle. Non era un marinaio come credevo ma un uomo di camera (sulle navi ospedale era rimasto il personale alberghiero militarizzato e il personale addetto alle pulizie delle cabine degli ufficiali, queste figure erano chiamate uomini di camera.)
Trovammo poi un pezzo di legno al quale ci appoggiammo. Certo che se ora trovassi in mare un pezzo di legno della grandezza di quello a cui ci aggrappammo mi guarderei bene dal prenderlo tanto era piccolo.
Però in quel momento tutto era buono. Intanto il tempo passava e noi eravamo sempre in mare. Si vedevano barche con sopra gente salvata che venivano portate sul Genepesca II e noi gridavamo per farci venire a prendere, anzi io chiamai per nome un ufficiale che vidi sull’imbarcazione dicendo che ero ferito ma la barca proseguì imperterrita.
Cercammo di nuotare attaccati al relitto verso terra ma la corrente ci portava sempre più al largo. D’altra parte io non potevo nuotare perché avevo la spalla lussata. Dopo due ore e mezza un’imbarcazione ci vide e ci tirò a bordo. Il mio compagno svenne e io poco dopo. La notte era limpida ma l’acqua fredda.
A borgo del Genepesca II due marinai mi portarono a braccia dal comandante. Il comandante aveva già distribuito alle sorelle e agli altri ufficiali tutto il suo guardaroba e non gli restava che quanto aveva addosso. Si spogliò e mi diede la maglia e le mutande di lana sue, belle calde. Le indossai. Il tepore della lana mi salvò da altri malanni. Mi misero a posto la spalla e dato che tutti gli altri letti erano occupati, tre sorelle mi fecero posto in mezzo a loro. Alle sei del mattino le autolettighe ci portarono in ospedale dove rimasi dieci giorni. Tutti assieme poi si partì con la nave ospedale California che ci sbarcò a Bari dove una vettura pronta per noi ci trasportò a Taranto. Qui due autobus ci trasportarono all’ospedale della Rondinella. Dopo otto giorni di cure partimmo per una licenza di 15 giorni.
A casa arrivai vestito per metà da soldato e per l’altra metà da marinaio ancora con il braccio al collo.
Al lettore lascio pensare l’accoglienza, lacrime di gioia… Pino era vivo grazie alla protezione del povero papà. Dopo otto giorni di licenza un telegramma (accidenti a questi telegrammi) mi annunciava di presentarmi a Bari per imbarcarmi sulla nave ospedale Sicilia».
Agosto 1941 – Ottobre 1943
sulla Vittorio Veneto
«Con il Vittorio Veneto uscite per esercitazioni di tiro… A Napoli durante la nostra permanenza ogni sera avevamo allarmi aerei e ciò per ben 28 sere consecutive. Ai primi di dicembre si lascia Napoli per Taranto. Il 14 dicembre arrivati all’altezza dello stretto di Messina un siluro scoppia a poppa all’altezza della torre tre da 381 e torre tre da 152. Sbandamento terribile della nave che quasi subito riprende la stabilità. Mentre il siluro ci colpiva io ero appoggiato alla battagliola con altri tre ufficiali… Proprio sotto di noi scoppiò il siluro e una doccia fredda ci avvolse scaraventandoci al centro della poppa dove si trovava il comandante in seconda intento a bere una tazza di caffè, che gli fu portata via dalla violenta pioggia.
Sono le 8.05. Ripresa la navigazione subimmo altri due attacchi che andarono a vuoto. L’acqua entrava dalla falla e riempiva i locali colpiti. Nei depositi munizioni della torre di poppa si trovavano una cinquantina di persone. Subito si scese nel secondo corridoio e si aprì il portello corazzato per cercare di liberare le persone. Infatti, appena aperto tirammo fuori persone semisvenute inzuppate di acqua e nafta. L’acqua continuava a entrare e per sicurezza della nave il comandante diede l’ordine di chiudere il portello. Avevamo già imbarcato circa tremila tonnellate di acqua!
Proprio in quel momento una testa affiorò dall’acqua, si prese per i capelli ma purtroppo scivolò. Il portello si abbassò inesorabilmente e il nostro cuore ebbe un sussulto. Due lacrime scesero dai nostri occhi nel pensare che sotto di noi ben 44 persone erano morte o stavano per morire. Quarantaquattro anime salivano al cielo avendo compiuto il loro dovere di soldati, ma quarantaquattro mamme non avrebbero più rivisto i loro figli. Quest’ultimo era il pensiero atroce che ci colpiva vedendo come questi ragazzi erano morti.
Purtroppo queste eroiche anime oggi non sono considerate e i loro cari penseranno inutile il loro sacrificio, ma questo non lo sarà mai per noi e per tutto l’equipaggio del Vittorio Veneto, perché in quel momento eravamo e continuiamo a essere compagni d’arme. Una lapide scolpita dai loro amici li ricorda e il presente scritto sta a testimoniare la loro continuità in mezzo a noi.
Arrivati a Taranto il comandante fa l’appello di tutto l’equipaggio per vedere gli assenti. Dopo 15 giorni si entra in bacino e di notte le 44 bare scendono dal bordo. Di notte e non con il frastuono del giorno, le salme vengono portate alle loro ultima dimora, perché i marinai amano il silenzio, il raccoglimento e in questi momenti vogliono sfuggire alle tentazioni del quotidiano per piangere da soli i compagni. Quella notte ogni quattro marinai portano un feretro e sopra ognuno il tricolore garriva ai raggi lunari e alle stelle che sembravano più luminose delle altre sere, quali uniche testimoni alla nostra mesta cerimonia.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie