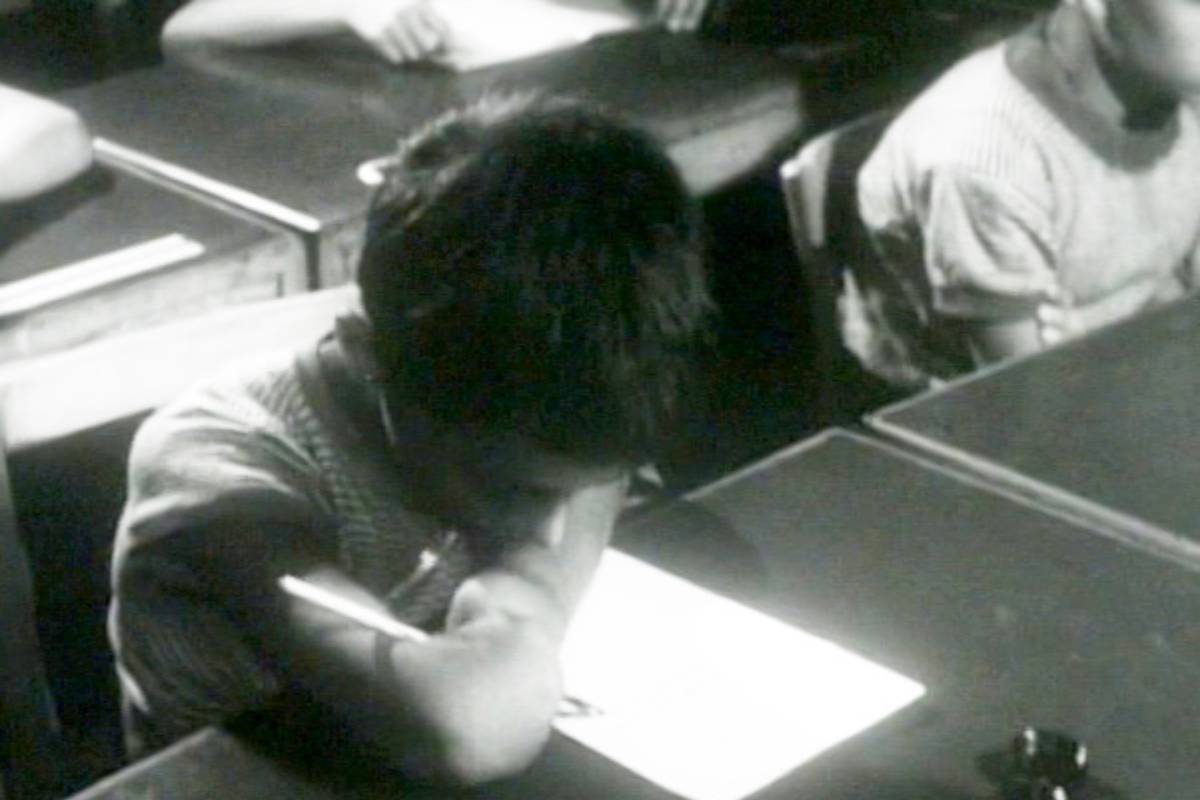Un'opera eccezionale e vigorosa, realizzata nell'anno stesso della canonizzazione di san Carlo, oggi presa come "icona" dell'incontra fra il cardinal Scola e il mondo della cultura milanese.
Luca FRIGERIO

Un episodio strano, un racconto sconvolgente. Giacobbe lotta con un uomo, nel silenzio della notte. Un uomo che non è uomo, in verità: il patriarca lo sa bene, e non cede, e non si lascia intimorire. Noi, invece, fatichiamo a capire. Leggiamo e rileggiamo la fine del trentaduesimo capitolo della Genesi, ma qualcosa continua a sfuggirci. Tutto è mistero, e noi assistiamo stupiti, attoniti.
“Assistiamo”, sì, perché a renderci la visione di questo incredibile passo biblico è un dipinto da Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Un’opera di sfolgorante bellezza, che coinvolge, che incanta. Una tela per quasi quattro secoli chiusa nelle sale del palazzo degli arcivescovi ambrosiani e ora finalmente accessibile a tutti, presso il Museo diocesano.
La lotta, dunque. Il volto di Giacobbe è segnato da rughe profonde, la fronte corrucciata, lo sguardo duro. Ma i muscoli sono tesi, i piedi ben saldi a terra, le braccia stringono in una morsa. L’“uomo”, qui ritratto come un angelo, si dibatte, cerca di strappare da sè quelle mani che l’afferrano, contorcendosi, piegandosi. Attorno a loro le tenebre che l’aurora sta per squarciare, gettando bagliori improvvisi a illuminare un volto, un polso, il lembo di una veste.
«Lasciami andare!», urla l’essere divino. Un ordine imperioso, che pare risuonare nel nostro sguardo. Ma il patriarca non molla, seppur ferito, seppur distrutto. Sa che qui, ora, in quest’istante, si gioca tutta la sua vita, e quella di un intero popolo. «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto!», ribatte con quanta forza gli è rimasta in corpo.
Inaudito, straordinario. Giacobbe strappa a Dio una benedizione, “la” benedizione, che da allora scenderà su quanti porteranno il nome di Israele. E, più in generale, diventa il simbolo di quel mistero che è l’incontro-scontro tra l’umano e il divino.
Morazzone realizza qui un’opera eccezionale, vigorosa, e tuttavia di squisita eleganza, databile al 1610, subito dopo aver conosciuto, cioè, l’arte di Gaudenzio Ferrari e quel suo sacro teatro così magnificamente rappresentato a Varallo. Ma qui c’è ancora qualcosa in più: una tensione mistica, un’ansia religiosa che scorre nelle membra delle figure, che scivola sui loro abiti dai riflessi metallici. E non si fatica allora a comprendere il perché questa tela avesse tanto entusiasmato il cardinal Monti, raffinato collezionista, premuroso pastore della diocesi di Milano nella prima metà del Seicento.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie