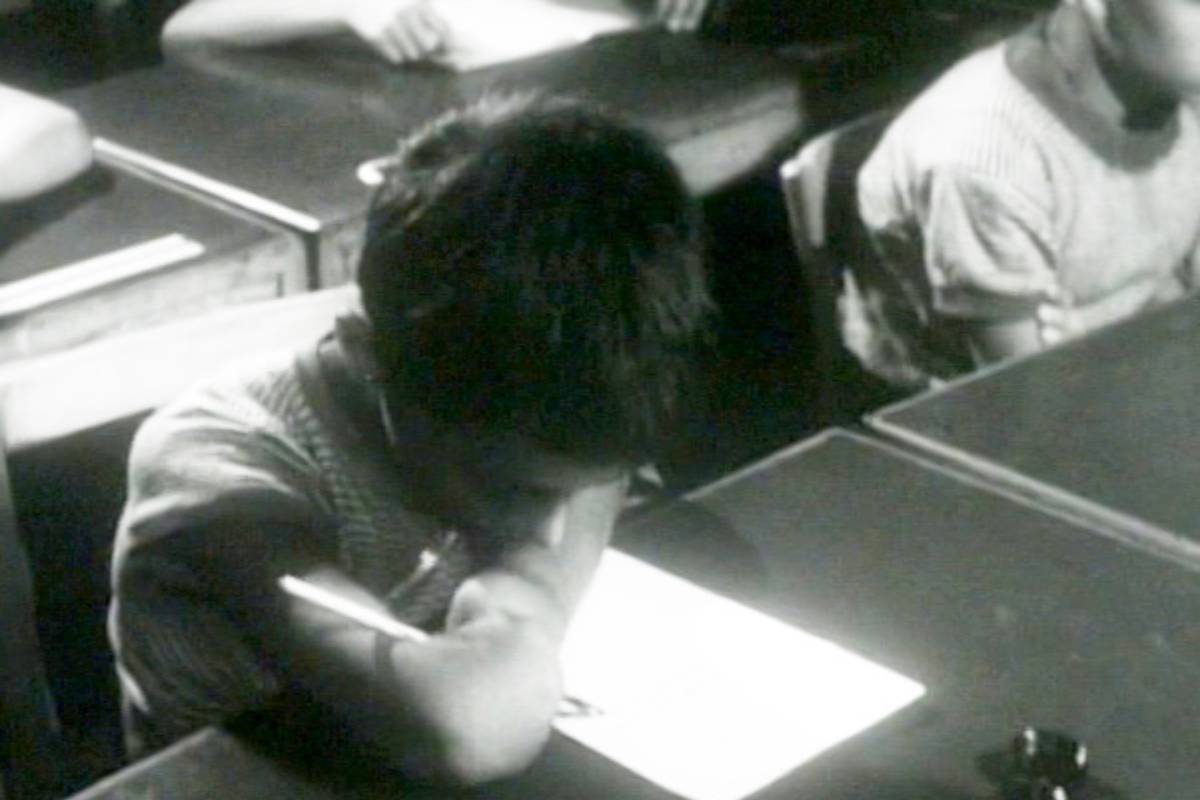Alla Galleria San Fedele di Milano, una riflessione, attraverso le opere di autori contemporanei ma dalla diversa sensibilità (Käthe Kollwitz, Mario Raciti, Bernardì Roig) su uno dei tempi più delicati e profondi.
di Andrea DALL'ASTA S.I.
direttore Galleria San Fedele

Nella mostra Al termine della notte, a cura di Andrea Dall’Asta S.I. e di Chiara Gatti, si intende riflettere su un tema universale di fronte al quale ogni tentativo di spiegazione pone un senso di disagio e di difficoltà: il dolore. Non ci sono parole efficaci per poterlo esprimere. Di fronte al dolore proprio o dell’altro che mi sta di fronte, si cade spesso nel silenzio. Ogni parola sembra di troppo, inutile. È un’esperienza estrema, difficile da tematizzare.
Nel dolore ci sentiamo lesi in ciò che per noi è vitale. Il dolore distrugge l’esistenza, la stravolge, l’annienta. Nel dolore ci sentiamo limitati, ci isoliamo, avvertiamo una lacerazione dentro di noi. Come suggerisce il termine greco pathos, ci sentiamo colpiti e privati di un qualcosa che viene a noi sottratto, come la salute, una persona cara, l’uso di una parte del corpo. Sperimentiamo la nostra radicale vulnerabilità e fragilità. Come nel caso di Giobbe, quando si vede in poco tempo cancellato quanto ha di più caro, come i beni, i figli, la propria salute… Che cosa ha compiuto, perché la sua fede verso Dio sia così messa alla prova? E questo accade senza poterlo decidere, controllare. Possiamo anche ribellarci, ma ci ritroviamo inerti di fronte a quanto risulta a noi imponderabile e incomprensibile. Lo subiamo. Passivamente. E nessuno può essere sostituito nel proprio dolore. Anche se l’uomo può condividere la sofferenza, ognuno è chiamato a giocare la sua parte. E ci interroghiamo. Perché a me e non a un altro? “A chi la tocca, la tocca”, dice Toni colpito dalla peste nei “Promessi Sposi” del Manzoni.
Perché sprofondare nella miseria, nella morte, nella guerra, sembra dirci Käthe Kollwitz (1867-1945), attraverso le sue drammatiche acqueforti. Come è possibile accettare la sofferenza? Certo, il dolore interroga sul senso ultimo della vita e del mondo. È tuttavia possibile attraversarlo e superarlo? C’è la speranza di una luce che non ci faccia precipitare nel baratro del non senso? Forse si tratta solo di bagliori – sembra dirci l’artista tedesca – che passano rapidi e fuggenti nella nostra vita, ma che permettono di sperare, come sembrano alludere veloci guizzi luminosi che attraversano le cupe incisioni.
Quando il dolore ci invade, le cose appaiono come inabissarsi e l’enigma del male sembra prendere il sopravvento. E il dolore si fa allora scandalo, perché riconduce a una dimensione di non-senso, all’abisso di fronte al limite, all’impossibilità di realizzare i nostri desideri più intimi e profondi. L’uomo si trova a superare una barriera che appare a lui insormontabile. Il dolore segna in questo modo l’esperienza notturna della vita, pone una domanda radicale sulla verità dell’esistere. Non a caso la città santa, la Gerusalemme celeste descritta nel libro dell’Apocalisse, alla quale è destinato l’uomo alla fine dei tempi, è avvolta da una luce perenne. La notte è scomparsa. Il dolore e il dramma dell’esistere umano sono risolti nella beatitudine della contemplazione di un Dio che è luce. Tutto qui si fa gioia, festa, pienezza di vita.
Questa tensione verso la luce attraversa tutta l’esperienza dell’uomo. Come accade nelle opere di Mario Raciti, che mette in scena l’esperienza umana dell’essere dilaniato, lacerato. “Why?” è il titolo di alcune sue opere recenti. È il grido dell’uomo di fronte al mistero della morte. L’artista milanese (1934) sembra riflettere sul grido di Cristo sulla Croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34). È questo il momento del suo trovarsi solo di fronte alla morte. Davanti all’interruzione di qualunque possibilità, di qualunque apertura. Come vivere questo abbandono di fronte al silenzio agghiacciante della notte che gli si squarcia davanti, per inghiottirlo, nella sua completa impotenza? E tuttavia, allo stesso tempo, esprime la sua fiducia nell’amore del Padre, principio della vita, in modo incondizionato. Cristo non chiede a Dio di scendere dalla Croce. Non si rivolge a un Dio potente di cui approfittare, per usare del suo potere. Non lo costringe a soccorrerlo nel suo desiderio di essere salvato. Non lo piega a un successo che costringe gli altri a “credere”. Non lo piega alle sue paure. E nelle tele di Raciti le mani non si chiudono su se stesse in un gesto di disperazione, ma si protendono verso l’alto, come per esprimere un gesto di abbandono e allo stesso tempo una richiesta dell’uomo di essere preso per mano, di essere accompagnato nel seno del Padre, per essere sottratto dalla morte. Il dolore non sprofonda nelle tenebre. Attraversandolo, ci troviamo come al termine di una notte oscura, ci affacciamo su di una realtà che si apre a una speranza. A una redenzione. E allora il dolore si apre a un “tu”, si trasforma in preghiera, in attesa di una risposta a un grido che altrimenti si farebbe varco solo in un gelido vuoto.
Il dolore è una dimensione ineliminabile della vita. Il dolore schiaccia, opprime. È come un peso che impedisce di vivere. Un carico di cui ci si vorrebbe liberare. Un fardello da scaricare. Il nostro corpo si trova separato rispetto al mondo. Nel Fedone Platone parla del corpo come di una prigione. E lo comprendiamo. Per l’uomo la sofferenza può risultare intollerabile, insopportabile. Come dare senso a quanto si presenta come “non senso”? Ci sarà un giorno in cui Dio asciugherà le lacrime su ogni volto (cfr. Is 25,8) come dice il profeta Isaia? Certo, attraversando il dolore, l’uomo può portare a compimento la propria vita. Tuttavia, il dolore può diventare anche il luogo di chiusura, di abbruttimento. Il dolore allora ci strazia, facendoci interrogare continuamente sul senso della vita, del mondo. Quale senso posso dare al mio esistere, se questo diventa intollerabile? Certo, il dolore può aiutare a crescere, a superare se stessi, ma se questo si fa lancinante, come è possibile sopportarlo, convivere con lui? Come dare senso alla vita se sperimento solo la dimensione di un lacerante soffrire senza speranza? Qual è il senso del mio destino?
E l’artista spagnolo Bernardí Roig (1965) è presente in mostra con due sculture in bronzo fortemente drammatiche. Sono volti concentrati su se stessi. Incapaci di parlare, di esprimere una parola. In Blackhead (2005), gli occhi sono chiusi, ma dalla fessura delle palpebre esce fuoco. Un’energia incontenibile sembra sul punto di esplodere dall’interno. È un volto bruciante, come se la sofferenza che abita quel volto impedisse al corpo di essere, di vivere. E lo immobilizzasse in un dolore che brucia, ma di cui non si vede riscatto, redenzione. Il suo volto è davanti a noi, nell’atrocità di un dolore senza senso. In Narcisus (2001), un volto simile si specchia davanti a una lastra di metallo. Non c’è alcun “tu” a cui rivolgersi. Solo uno specchio. Un dolore si riflette davanti a se stesso. Profondo e radicale. È come se il corpo fosse rappresentato nella sua chiusura, nel suo porsi come ostacolo verso il mondo. Quando il nostro corpo è ferito, non sentiamo più la bellezza e il piacere del mondo in cui siamo immersi, quanto piuttosto percepiamo solo… la solitudine di un inutile soffrire. E il corpo si fa allora limite, barriera. Il corpo malato o ferito non avverte tanto il mondo, quanto piuttosto “sente” il proprio corpo che grida. E il dolore allora schiaccia. Inchioda in un’esperienza di separazione dal mondo che può trasformarsi in disperazione, urlo privo di speranza. In un dolore in cui la notte non sembra mai conoscere fine.
Come liberare la vita in quell’oscurità? Come aiutare l’altro a vivere, attraverso la sua sofferenza? Probabilmente non ci sono parole. Forse, è possibile solo uno sguardo, in cui diciamo a chi soffre il suo essere importante per noi, il suo essere prezioso ai nostri occhi. Il nostro soffrire e vivere con lui. Per aprirgli una speranza nel Dio della vita.
Al termine della notte. Käthe Kollwitz, Mario Raciti, Bernardì Roig
Galleria San Fedele, Via U. Hoepli 3 a/b, Milano
Fino al 21 aprile 2012
Orari e ingresso 16,00-19,00 dal martedì al sabato (mattino su richiesta),
ingresso libero




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie