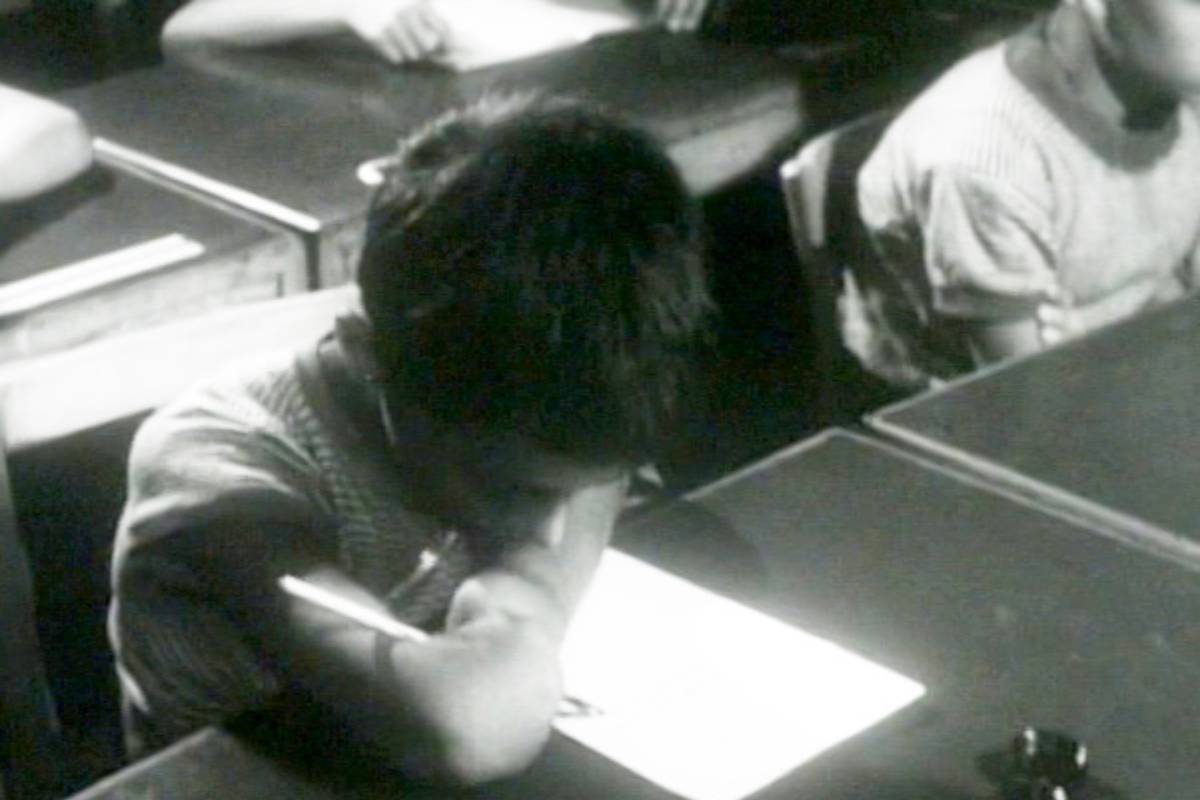Con un dialogo tra l’Arcivescovo e la giornalista, Marina Corradi, si è concluso il ciclo di incontri. promosso dal Centro Culturale di Milano, dedicato al rapporto tra Dino Buzzati e la città contemporanea
di Annamaria
BRACCINI

Incerto sulla soglia del mistero, spaventato dalla solitudine, lontano dalla pratica religiosa, eppure aperto alla domanda dell’“oltre”. Dino Buzzati, scrittore, giornalista famoso, interprete delle inquietudini del dopoguerra e del boom economico, scomparso quasi 50 anni fa (moriva nel 1972) come pochi ha saputo raccontare la vita umana. Da quella spicciola a quella delle grandi domande, dall’inferno della Milano anni ’60, immaginato nelle viscere delle metropolitana in costruzione, al “Deserto dei Tartari” con la sua attualissima “fuga del tempo”. E così il ciclo di incontri «Scusi, da che parte per piazza del Duomo?», incentrato sul rapporto tra Dino Buzzati e la città contemporanea, promosso dal Centro Culturale di Milano e curato da Alessandro Zaccuri, si conclude come meglio non si potrebbe, dopo un cammino iniziato esattamente un anno fa, ma interrotto, nel marzo scorso, dal lockdown e, poi, ripreso in autunno sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del CmC. A dialogare, infatti, su Buzzati “Testimone delle metropoli” (titolo dell’appuntamento) sono l’Arcivescovo e Marina Corradi, firma di punta del quotidiano “Avvenire”. A fare da filo conduttore due celebri reportage di Buzzati, ai quali ha dato voce l’attore Giorgio Bonino: il ritratto di don Zeno Saltini, fondatore di Nomadelfia, e la cronaca, per il “Corriere della Sera”, dello storico viaggio a Gerusalemme di Paolo VI nel 1964.
«Buzzati mi ha impressionato perché vede lo squallore, soffre la solitudine, tuttavia, mi pare che, non avendo la speranza di un oltre promettente, abbia come una pietà, un senso di compassione per la città, per gli uomini. Il senso del mistero, che si ritrova in tutti i suoi racconti e romanzi, rivela una sensibilità, un cuore, una richiesta di consolazione e di compassione. La grande domanda su Buzzati è se attende qualcosa o se ritiene che vi sia qualcosa di disperato nel vivere che induce a cercare una compagnia, non avendo, però, nessun segnale che veramente esista un oltre», nota, in apertura del dialogo, condotto dallo stesso Zaccuri, il vescovo Mario. Quasi rispondendo ai ricordi di Corradi, l’unica tra i relatori della serata ad avere conosciuto Buzzati, quando era bambina, essendo vicino di casa della sua famiglia (il padre Egisto, era anch’egli uno dei più famosi inviati del “Corriere”). «Mi impressionavano i suoi occhi, scuri, gentili, intensissimi, il suo sguardo di dolore che emerge per intero nel racconto dell’inferno in metropolitana». Una Milano spesso narrata dalle colonne della “nera” quotidiana che, tuttavia, porta – in un viaggio simbolico, ma compiuto realmente dal giornalista – ad altre città possibili come la Nomadelfia di don Zeno Saltini, forse il prete più amato da Buzzati che lo dipinge «con maestria e capacità, perché è più facile raccontare il male che il bene».
Il ritratto, tratteggiato ne “L’usignolo di Nomadelfia” (1965, in Dino Buzzati, “Cronache terrestri”) definisce un “oltre” che esiste ed è molto vicino, «con una presenza familiare dell’Eucaristia», secondo Delpini.
«Buzzati, anche a Nomadelfia come fa spesso, tende l’orecchio e sente l’usignolo e questo è segno dell’attesa. Il destino è l’inferno del sottosuolo o altro?», si chiede la giornalista. In fondo, dipende da noi – osserva Zaccuri – richiamando l’intuizione buzzatiana e declinandola nel momento attuale di pandemia, con i suoi rischi di paralisi dello spirito, e in rifermento all’idea di fraternità presente nell’ultima Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”.
«Dobbiamo domandarci – spiega Delpini – cosa vi sia oggi nella città, quanta fraternità e quanta paralisi che isola. Sento continuamente racconti di forme di ricerca degli altri: giovani che vanno a fare la spesa per persone in difficoltà; preti che si ingegnano, attraverso i media, per stare vicino alla gente. Quando parlo di paralisi dello spirito intendo non tanto la mancanza di gesti di attenzione, generosità e servizio, ma una sorta di inaridimento che sta come sospeso e non si decide a sperare, a guardare il mondo come una possibilità di bene. Nell’ambito circoscritto che ci è dato – che è questo in cui viviamo – mi pare che non fiorisca un cantico di speranza. A questo occorre mettere rimedio. Il rimedio è che entri una luce, quella stella che aiuta chi cerca a trovare una strada».
La via di un Dio che si incarna nel mondo che non è mai non perfetto, nascendo in Terra Santa, dove si reca, primo Pontefice nella storia, san Paolo VI dal 4 al 6 gennaio 1964. Uno degli inviati, allora, fu Buzzati – un altro nome per tutti, Eugenio Montale – che descrisse con pennellate di rara bravura l’immensità della folla variegata che circondò ovunque, a Gerusalemme fino alla Celebrazione ai Getsemani, il Papa. «Intorno a me – scrive Buzzati schiacciato dalla stessa folla – si ansima in americano, si supplica in torinese, si geme in tedesco, si protesta in arabo, si sviene in portoghese» (“Dinanzi alla pietra dell’agonia di Gesù il Papa concluse una faticosa giornata”, in Dino Buzzati, “Con il Papa in Terrasanta”). Quel Paolo VI, inginocchiato davanti alla pietra dell’agonia, che ancora oggi ci scuote leggendo il reportage e vedendo le immagini di allora. «Nel racconto di Buzzati – sottolinea il vescovo Mario – vedo soprattutto una sorta di disagio per la spettacolarizzazione dell’evento. La domanda se non sarebbe stato meglio un momento più raccolto, come dice a conclusione, non so se sia un apertura verso il mistero, una richiesta spirituale o estetica». E tornano, così, alla mente la preghiera di papa Francesco, solo sul sagrato di San Pietro sferzato dalla pioggia nel buio della sera del 27 marzo scorso e la preghiera dell’arcivescovo salito, sotto un cielo di Lombardia azzurrissimo “così bello quando è bello”, l’11 marzo, tra le guglie per affidare a Maria Milano e il mondo intero. Gesti che Buzzati avrebbe potuto raccontare, rispondendo idealmente alla domanda posta ai lettori e a se stesso al termine della cronaca da Gerusalemme. E, forse, avrebbe chiesto anche lui al vescovo Mario, come fa Zaccuri, il perché del salire fino alla Madonnina.
«È stata un’intuizione. Il Vescovo di Milano deve guardare tutta Milano. In quel momento in cui la città era silenziosa e ferma, ho voluto ribadire che, anche se sotto c’è il caos o il deserto, la Madonnina è sempre lì, con una presenza materna che intercede sempre per noi, nei giorni della frenesia, dell’affollamento, e in quelli della solitudine e della depressione . L’idea di andare ai suoi piedi mi è sembrata coerente con il guardare la città avendone pietà nel suo insieme e chiedendo a Maria di intercedere per noi». L’idea, come credo suggerisca Buzzati, che il mistero lo si intuisca solo nella solitudine, di cui tuttavia si ha paura, è un dramma molto personale. Per i cristiani si entra nel mistero facendo parte di una comunità che prega».
Anche Corradi si sofferma sull’idea di fede. «Tante generazioni, come la mia, sono cadute nell’equivoco di un moralismo dove la fede significava essere bravi. Ciò contro cui si schierò don Giussani, che insegnò che prima viene la comprensione di essere amati e per questo si ama. Forse gente come mio padre e Buzzati si sono allontanati dalla fede per il trauma subìto dalla guerrae questo moralismo».
E il trauma, oggi, della pandemia? Chiara la risposta dell’Arcivescovo: «Prego e spero che si rivolga lo sguardo su Gesù perché ci conduca a Dio». Insomma, un tempo che può essere occasione per scoprire Dio «che non manda o toglie le epidemie, ma che è quello che manda il Figlio per mostrare la via che conduce a salvezza»
«La salvezza significa essere resi partecipi della vita di Dio. Questo è il dono che ci porta Gesù e per cui siamo chiamati a vivere come lui. La nostra cultura non riesce ad ammettere che il Signore sia risorto e, perciò, censura il tema della salvezza. Però l’annuncio del Vangelo è inequivocabile e anche semplice da vivere se cui affidiamo e ci fidiamo».








































 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie