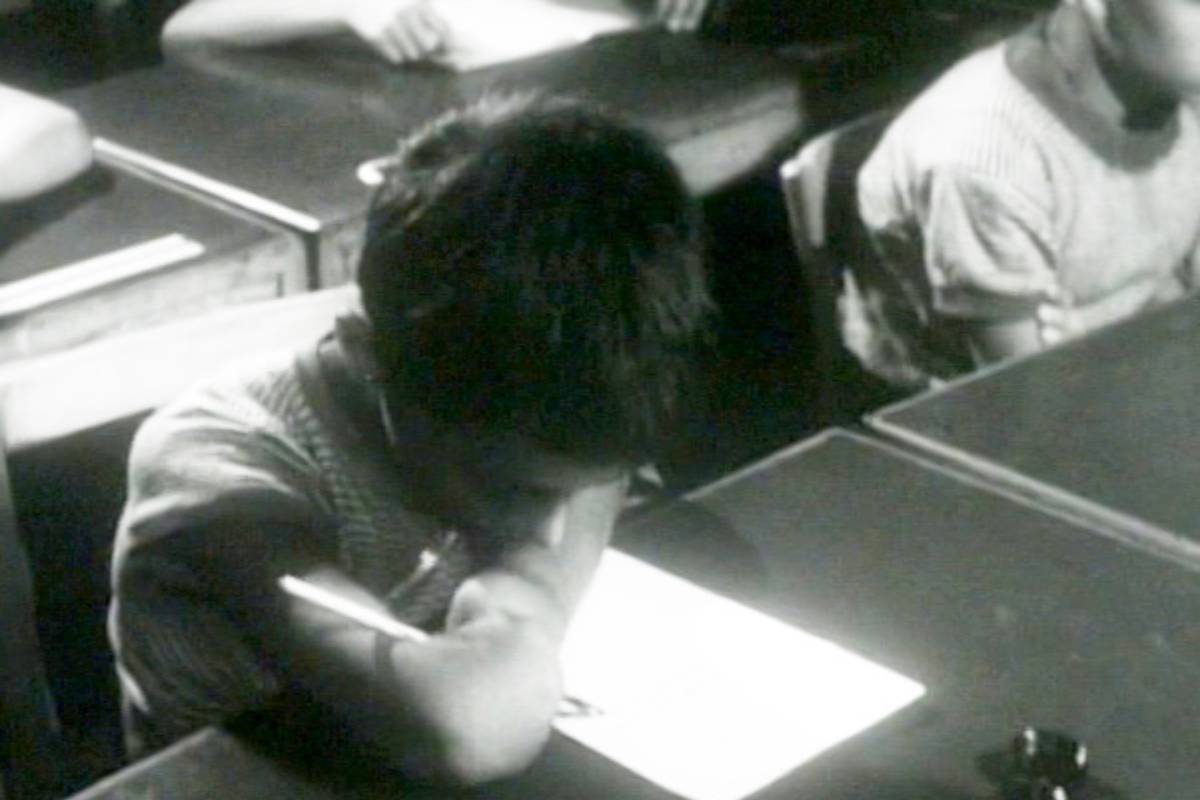Lo storico dell'arte e gallerista, notissimo volto televisivo e autore di molti libri di successo, è morto a 70 anni presso l'Istituto dei tumori a Milano. Alcuni anni fa lo avevamo intervistato sulla situazione culturale del nostro Paese: intervista che qui riproponiamo.

di Luca
Frigerio
È morto Philippe Daverio. Lo storico e critico d’arte, noto volto televisivo e autore di numerosi bestseller è deceduto questa notte all’Istituto dei tumori di Milano. Era nato a Mulhouse, in Alsazia, il 17 ottobre 1949 da padre italiano, Napoleone Daverio, costruttore, e da madre alsaziana. Come gallerista ed editore ha allestito molte mostre, e pubblicato una cinquantina di titoli. È stato assessore alla Cultura del Comune di Milano dal 1993 al 1997 nella giunta Formentini. Direttore della rivista Art e Dossier, nel 2014 era stato nominato direttore artistico del Museo del Duomo di Milano.
Fa un certo effetto trovarsi seduti in poltrona in un set televisivo. Soprattutto se il set televisivo, in realtà, è il salotto della persona che si è in attesa di intervistare. In attesa, appunto. Philippe Daverio è in ritardo al nostro appuntamento. Ma la cosa, per ora, non ci preoccupa: i telefoni, al di là della porta a doppia battente, non cessano un attimo di squillare, così come il citofono e il campanello. Sono artisti che chiedono una presentazione alle loro mostre, assessori che sondano la possibilità di un intervento, editori che propongono nuovi titoli, colleghi giornalisti che avrebbero un paio di domande da fare…
La sala in cui si registra Passepartout è una sorta di “camera delle meraviglie”, non diversa da quella ci saremmo aspettati. Su librerie e scaffali, volumi d’ogni genere e tipo, adatti a un appetito onnivoro: poesie, romanzi, saggi storici e letterari, cataloghi d’arte, in almeno quattro lingue diverse. Alle pareti, dipinti piccoli e grandi, figurativi, astratti, surrealisti. Nelle vetrine, di tutto un po’.
Philippe infine arriva ed è pronto ad accoglierci: cordiale, e forse anche un po’ incuriosito dal fatto che la stampa diocesana l’abbia voluto interpellare.
Daverio, lei si sente più italiano o francese?
Mio nonno era varesotto. Nell’Ottocento è partito per l’Alsazia, dove è nato mio padre, che quindi era più crucco che italiano. Io sono nato e cresciuto lì, e sono venuto in Italia a fare l’università. Il mio, dunque, è un caso curioso, perché la lingua che parlo e che scrivo in realtà non l’ho imparata a scuola, ma con la prassi: non so niente di grammatica italiana, io… (Ride, ndr). E la letteratura italiana che conosco, la conosco come può averla letta uno straniero dell’Ottocento innamorato del Bel Paese.
E questo l’aiuta a capire meglio l’Italia?
Certo non sono più un immigrato della prima ora, ma mi rimane sempre una certa tendenza a guardare l’Italia dal “di fuori”… Del resto, la mia incapacità assoluta di affrontare la parte più sofisticata della cultura italiana, che è quella che io chiamo “ginnasiale”, mi mette in una posizione “eccentrica”, cioè meno avvezzo al pensiero complesso del politichese, del giornalistichese, del critichese e di altri vari “esi”, rendendomi forse più diretto. E questo, probabilmente, anche perché la mia formazione non ha un riferimento stabile: io parlo allo stesso modo italiano e francese, ho praticato per tanti anni l’inglese quando avevo la “bottega” a New York, me la cavo con lo spagnolo, e la mia lingua materna è l’alsaziano, cioè un dialetto tedesco. Penso che parlare diverse lingue serva a guardare le cose da vari punti di vista: aiuta la trigonometria cerebrale. Cambiando posizione, cioè, si riesce a intuire cose diverse.
Gallerista, editore, critico d’arte, autore di programmi televisivi, docente universitario… Qual è il ruolo che le si addice di più?
Dopo tanti anni ho capito che la faccenda seria sta nel rapporto col “piano di sopra”… (Si tocca la testa con l’indice, ndr) Se uno sta attento e l’ascolta, le cose vengono meglio. Del resto io sono convinto che esista una sorta di guida provvidenziale delle esistenze. Quello che io faccio oggi, vent’anni fa non mi sarei mai immaginato di poterlo fare. Io sono arrivato in Italia nel ’68 per frequentare la Bocconi, e come tutti in quegli anni non mi sono laureato (anche perché, allora, alla Bocconi non ci si andava per laurearsi, ma per studiare), mentre oggi sono diventato professore di ruolo di architettura all’università di Palermo… Sinceramente, non ci avrei mai pensato, allora. Così come sono arrivato a Milano che parlavo male l’italiano e sono finito con giocare un ruolo nell’amministrazione della città. L’esistenza è un percorso molto bizzarro, che uno comprende solo dopo che le cose sono successe.
Oggi lei è un volto televisivo. Le sue trasmissioni hanno un buon riscontro, non solo di critica, ma anche di pubblico. Anzi, molti dicono di essersi avvicinati a certi temi dell’arte e della cultura soprattutto grazie a lei…
Francamente non me l’aspettavo neanche io. Molto lo si deve alla genialità del capostruttura (di Raitre, ndr): «Non preoccuparti», mi da detto. «Tu puoi entrare in una cabina telefonica a leggere l’elenco e la gente ti segue lo stesso». Detto così, però, è come se io fossi un anchorman, definizione che mi dà un forte senso di disagio. La verità è che è possibile trasmettere la passionalità. Io, infatti, non faccio divulgazione, ma racconto le mie scoperte. In televisione, alla gente, io non dico quello che c’è scritto in un libro, ma cerco di raccontare ciò che io stesso vivo come percorso di riconoscimento e di indagine. E chi mi ascolta procede con me.
Insomma, si può fare cultura in televisione senza essere noiosi o accademici.
Sì, ma bisogna uscire da quell’idea paludata che chi si occupa di questioni intellettuali è superiore agli altri. E poi si deve abolire quella lingua liceale che si usa di solito in questi casi. Le mie trasmissioni, ad esempio, sono seguite anche da un pubblico non particolarmente colto, che cioè è interessato a certi argomenti culturali non per formazione, ma proprio per inclinazione. Io credo che certe cose in televisione “passano”, anche parlando di argomenti complicati, se si solletica l’attenzione degli specialisti e allo stesso tempo si è capaci di coinvolgere chi non ne sa niente.
D’altra parte a Milano, come in altre città d’Italia, quando si fanno degli incontri su Dante, su Omero o su Manzoni, le sale e le piazze si riempiono.
Noi oggi viviamo in una società che è ossessionata dal timore di non capire più nulla. E dove non ci sono più guide. Il tutto complicato da una situazione geopolitica mondiale che desta forti preoccupazioni. Tutto ciò crea una forte pressione culturale. Una pressione, tuttavia, che non necessariamente diventa una domanda.
Cioè?
Nelle cose della cultura nasce sempre prima l’offerta, non la domanda. Questa è una grande lezione che ho imparato quando gestivo gli spazi della cultura milanese: all’offerta di un prodotto di qualità corrisponde sempre una grande risposta del pubblico. Allora mi chiedo: perché i nostri politici non si occupano di più di prodotti di qualità?
Forse perché c’è tanta ignoranza…
Ricordo che al momento del loro insediamento, nei mesi scorsi, alcuni dei nuovi parlamentari sono stati “interrogati” sui momenti chiave della storia dell’umanità (come la scoperta dell’America o la rivoluzione francese), ma la maggior parte ha fatto scena muta… Certo, perché la crisi in una società è trasversale. E da noi è in crisi anche l’attuale classe dirigente. Se le stesse domande fossero state poste ad Andreotti o a Napolitano, questi avrebbero risposto senza difficoltà. Sono i nuovi che non sono stati formati.
Visto che siamo in argomento, qual è il suo rapporto con la politica?
In Italia la politica è diventata una professione. Del resto il nostro è il Paese della Controriforma: come il prete per essere tale deve essere consacrato, così il politico deve essere di carriera. Se no, che politico è? Io penso comunque che l’uomo debba essere politico, nel senso più ampio e più positivo del termine. In Italia non c’è più il servizio militare obbligatorio, ma io credo che tutti dovrebbero fare un servizio nella società: non necessariamente nel consiglio comunale, ma anche nel proprio quartiere o nel proprio condominio… Partecipare alla vita sociale è fondamentale, un po’ per spirito di servizio, un po’ per formazione personale.
D’accordo, ma lei politicamente come si colloca?
Con grande difficoltà. Ho ovviamente delle inclinazioni e delle passioni, delle simpatie e delle antipatie. Io mi definirei tendenzialmente gollista, cioè mi interessano certi temi che di norma sono patrimonio della destra, come la difesa delle istituzioni, della sanità o della scuola pubblica: valori, invece che da noi sono portati avanti dalla sinistra. L’Italia è un gran pasticcio.
E la sua esperienza di assessore del Comune di Milano, con un sindaco leghista, come la ricorda?
Come un’esperienza molto calda, impegnativa e difficile. Sono contento di averla fatta, e penso anche di aver lasciato delle tracce. Ma Milano è un mondo davvero particolare rispetto al resto d’Italia. La città ha una reattività bizzarra: se ai milanesi si dà del fois gras di prima qualità, lo apprezzano e lo gustano; e se poi si torna a dargli della mortadella rancida, per loro va bene lo stesso, non protestano…
Sì, credo di capire. Ma com’è la situazione culturale in Italia?
Catastrofica. Oltre ogni livello d’allarme. E questo perché gli italiani sanno di avere un grande patrimonio culturale, ma proprio per questo se ne fregano, credendo di avere la coscienza a posto e rinunciando a fare alcunché. Invece proprio la cultura è il momento più potente della nostra identità, se non vogliamo essere messi totalmente in disparte dal resto del mondo. Per quanto riguarda il nostro rapporto con la creatività, poi, siamo stati bombardati da un messaggio americano che ci ha detto che eravamo dei cani e ci abbiamo creduto. Così in Italia facciamo solo mostre di cialtroni assoluti inventati dal mercato tra Londra e New York, e siamo anche disposti a genufletterci e a pagare per averle. Con quei soldi, invece, potremmo rimettere in vita le energie locali, che sono potentissime ma totalmente dimenticate. Lo ripeto: oggi in Italia la cultura non può più essere un privilegio dei ricchi, ma una necessità complessiva di tutti. Ne va del nostro futuro.
E Milano come è messa, da questo punto di vista?
Molto male. Anche gli ultimi interventi urbanistici a Milano sono tutti di architetti stranieri. È come se avessimo deposto le armi… Siamo un paese che non ha più voglia di competere.
Ma non è che, da parte di chi oggi fa cultura, occorrerebbe un atteggiamento un po’ più “nazional-popolare”?
Io non credo al nazional-popolare. E’ un’idea perversa, perché vorrebbe abbassare il livello del discorso culturale per il “popolo” reputando che da qualche parte esiste un’élite capace di capire di più. E questo va contro tutta la nostra storia. Infatti questo è un concetto che è nato di recente, perché serve a legittimare la mediocrità della stampa e l’assoluta modestia della televisione.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie