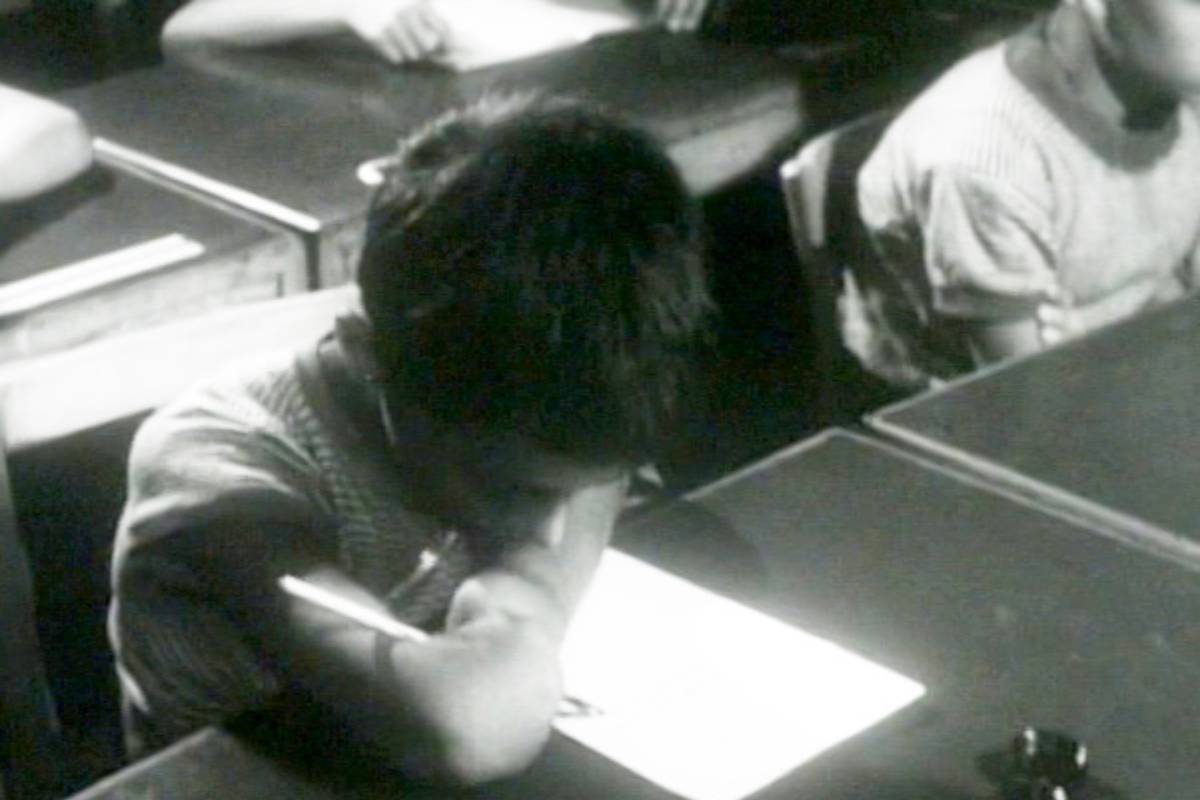È morto ieri sera, nella sua casa di Pettenasco (Novara), Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 aprile. Nato a Milano nel 1920, nella sua lunghissima attività, Tedeschi ha lavorato con i più grandi registi, da Luchino Visconti a Giorgio Strehler a Luca Ronconi, ma è stato anche volto del varietà e della pubblicità in tv con Carosello. La sua “carriera” era iniziata nei lager nazisti, dove era stato internato dopo l’8 settembre 1943 perché non aveva voluto aderire alla Repubblica di Salò. Come aveva raccontato in questa testimonianza, raccolta nel 2008 nel libro "Noi nei lager" (Paoline Editrice).

di Luca
FRIGERIO
«Sì, è stato nei lager che ho capito che la mia strada era il teatro». Fa un certo effetto sentire pronunciare queste parole dalla viva voce del grande, amatissimo attore italiano Gianrico Tedeschi. Anche lui, infatti, ha subito la dolorosa esperienza dell’internamento nei campi nazisti, come racconta in uno dei suoi ultimi spettacoli, Smemorando, che instancabilmente e con continuo successo porta in giro, tra gli altri, per la Penisola. «Alla mia età, del resto, non fa bene riposarsi troppo», ci spiega, serio, senza civetteria, la chioma canuta che è ormai diventata il suo tratto distintivo e uno sguardo intenso, insistito, quasi a valutare la disponibilità a comprendere di chi gli sta davanti.
Classe 1920, due anni, dal 1943 al 1945, passati in prigionia, tra i reticolati, la fame e i pidocchi. Tedeschi narra con fare ispirato, ora lentamente, ora con rapidità, con pause di riflessione in cui i suoi occhi paiono velarsi, forse rivedendo quei giorni, rivivendo quelle emozioni. È un attore, certo, ma non c’è nulla di teatrale, nessuna maniera in questo suo svelamento di ricordi. Semmai un pudore che induce rispetto.
Nel 1943 era in Grecia, ci racconta. Sottotenente di fanteria, uscito dall’accademia per ufficiali di Pistoia due anni prima e mandato a dare la caccia ai partigiani tra i monti della Tessaglia. «Ci aggiravamo sul Parnaso e sull’Olimpo, ma della poesia e della bellezza che quei luoghi avevano evocato nei nostri studi liceali trovavamo ben poco», confessa Tedeschi. «Vivevamo infatti in un continuo stato di tensione e di guerriglia, sotto la minaccia di attacchi e di sabotaggi. Anche se gli inglesi, con un certo disprezzo, ci avevano definito “l’Armata s’agapò” (“ti amo”, ndr), facendo allusione al nostro scarso senso militare, vero o presunto, e alla facilità, reale, con cui facevamo “amicizia” con la popolazione locale. Ma restava il fatto che laggiù si rischiava la pelle ad ogni momento».
«DEPONETE LE ARMI»
Quando arrivò l’8 settembre, Gianrico non era certo l’unico ad averne abbastanza di quella vita, della guerra e del fascismo. Ma non ci fu tempo per decidere niente. «Nelle ore immediatamente successive all’annuncio dell’Armistizio», ricorda, «dal nostro comando ad Atene giunse subito l’ordine di deporre le armi. Forse avremmo potuto fare come a Cefalonia, cioè resistere ai tedeschi combattendo, ma nessuno di noi, in quel momento si sentì di fare l’eroe». Vennero allora le SS, catturarono i militari italiani e dopo alcuni giorni li fecero salire su dei convogli ferroviari: «Noi ufficiali dentro delle carrozze chiuse. I soldati, invece, stretti gli uni agli altri su dei pianali scoperti, con una temperatura che si faceva già rigida», spiega Tedeschi. «A un certo punto, poi, ci caricarono tutti su dei vagoni merci. Ricordo perfettamente la scritta che c’era su una paratia: “Cavalli 8, uomini 40”. Ma noi eravamo ammassati in settanta, e potevamo sdraiarci solo a turno, mettendoci uno per i piedi e l’altro per la testa».
Il viaggio, infernale, durò quasi due settimane, con soste estenuanti sui binari per lasciar passare i convogli militari tedeschi, che avevano la precedenza. Ma i portelloni si aprivano soltanto una volta ogni quarantotto ore, quando ai deportati italiani veniva data un po’ di sbobba e il permesso di scendere dai vagoni per i loro bisogni. «Una cosa pazzesca», commenta l’attore. «Io ero tra i più giovani, con i miei 23 anni. Ma gli altri, soprattutto gli ufficiali più anziani, avevano anche 40, 50 anni. E se era dura per me, ci si può immaginare cosa deve essere stato per loro. C’era chi aveva la febbre, chi aveva dolori, chi era in preda a crisi di nervi e sembrava impazzito…». La frase resta come sospesa, mentre Gianrico Tedeschi fissa un punto fuori dalla finestra, il labbro un poco tremulo, la mano che tamburella nervosamente sul tavolo. Dalla strada sale lo sferragliare di un tram, lontano eppur agghiacciante.
LA BIBLIOTECA NEL LAGER
Quello di Beniaminowo, in Polonia, non lontano da Varsavia, fu il primo campo dove l’attore milanese venne internato. «Sin dall’inizio abbiamo subito una forte pressione per farci aderire alla Repubblica di Salò», spiega Tedeschi. «Ma pochissimi hanno firmato il giuramento a Hitler o a Mussolini, e quelli che l’hanno fatto, l’hanno fatto per paura e per fame. La maggior parte di noi, invece, non voleva più avere nulla a che fare con quella guerra, nè collaborare in alcun modo con i nazisti e con i fascisti. E nessuna minaccia, neanche il rischio di essere fucilati, ci ha fatto cambiare idea». «Ha dell’incredibile», aggiunge dopo una breve pausa, «come in noi tutti, nati e cresciuti negli anni del regime, si sia sviluppata la coscienza e la consapevolezza di cosa era giusto fare in quel preciso momento…».
Ma fu poco più tardi, nel lager di Sandbostel, che ebbe inizio l’attività teatrale di Gianrico Tedeschi. «Il nostro campo sembrava una piccola città», ricorda l’attore. «Eravamo in cinque o seimila, tutti ufficiali, molti dei quali giovani come me. C’erano quindi studenti universitari, diversi docenti e tanti professionisti: architetti, medici, avvocati, ingegneri… Ben presto alcuni di noi cercarono di mettere al servizio degli altri le loro conoscenze e le loro capacità, per far passare il tempo cercando di non pensare troppo a quella nostra disgraziata condizione. C’era chi teneva conferenze come Enzo Natta e il filosofo esistenzialista Enzo Paci; chi organizzava corsi come Giuseppe Lazzati; chi si dedicava alla pittura come Novello; chi allestiva dei veri e propri concerti come il violoncellista Angelo Selmi, che pur non avendo il suo strumento riuscì a fare un’esecuzione memorabile usando un… violino! Io, invece, prima della guerra, avevo fatto parte della filodrammatica della mia parrocchia, e mi piaceva andare a teatro. Così pensai che potevo mettere in scena qualcosa…». Già, ma che cosa?
Nel lager c’era una biblioteca, per quanto possa sembrare incredibile. Una biblioteca che la maggior parte degli internati italiani aveva contribuito ad arricchire. «Ognuno di noi, infatti, era riuscito a portarsi dietro dei libri», spiega Tedeschi. «Io, ad esempio, studente di Magistero alla Cattolica, avevo con me tre volumi di storia della filosofia, su cui avrei dovuto preparare il relativo esame. Altri avevano testi di narrativa, o manuali scientifici, o altri scritti ancora, che venivano messi in comune, a disposizione di tutti. E fra quei volumi sono riuscito a trovare un testo di Pirandello: l’Enrico IV».
Farne una rappresentazione non era certo una cosa facile. Soprattutto se si è internati in un campo di prigionia, con i crampi allo stomaco dalla fame e con le forze ridotte al lumicino… Ma Tedeschi ci si mise di impegno, e riuscì a coinvolgere nell’impresa altri compagni, chi per le scenografie, chi per i costumi (fatti con degli stracci), chi per i diversi ruoli, compresi quelli… femminili! Fu un successo. Un successo che si ripetè più avanti con un altro dramma pirandelliano, L’uomo dal fiore in bocca, e poi ancora con Gli Spettri di Ibsen.
«Fu una sorpresa anche per me», confessa l’attore. «Pur avendo già recitato, non avrei mai pensato prima di allora che il teatro sarebbe potuto diventare la mia vita. A convincermi, fra i tanti che si complimentavano con me e che mi incitavano a continuare, fu Clemente Rebora, anche lui lì internato e già apprezzato critico teatrale: “Tu sei nato per fare l’attore”, mi disse un giorno. “Ne hai proprio la stoffa”. E io gli ho dato retta».
Ma non solo testi impegnati riuscì a mettere in scena Tedeschi. Grande apprezzamento, naturalmente, ebbero anche spettacoli più leggeri e divertenti, alcuni ideati dall’incontenibile genio creativo di Guareschi, suo compagno di prigionia a Sandbostel e a Wietzendorf. «Una volta io e Giovannino abbiamo messo in piedi una “rassegna d’arte varia”», ricorda Gianrico. «Con noi c’era anche Coppola che suonava la fisarmonica, ma dove sia riuscito a trovarla davvero non l’ho mai capito…».
CARDUCCI E TECOPPA COME… ARMI!
E i tedeschi? «I tedeschi per lo più lasciavano fare», spiega l’attore. «E tuttavia ci tenevano sotto stretto controllo, assistendo agli spettacoli e spesso anche alle prove. Mettevano in atto una sorta di censura preventiva, e se solo avevano il sospetto che si sarebbe detto qualcosa contro Hitler, Mussolini o il Reich facevano subito sospendere tutto».
Insomma, interveniamo noi un po’ provocatoriamente, in quegli spettacoli non c’era nessuna critica verso i vostri aguzzini… «Come no!», esclama Tedeschi, scaldandosi. «In realtà cercavamo in tutti i modi di prenderli in giro e di sfotterli: era quella la nostra piccola rivincita. Ma bisognava farlo con intelligenza, sfruttando i loro momenti di assenza o facendo allusioni che loro non riuscivano a cogliere. Una volta, ad esempio, ho preso un testo allora famoso e piuttosto divertente, L’anglais tel qu’on le parle, di Bernard Tristan, che Edoardo Ferravilla aveva tradotto in milanese per il suo celebre personaggio di Tecoppa, e l’ho riscritto in chiave anti-germanica: è stata una cosa da far venir giù la baracca dalle risate. Se i tedeschi fossero arrivati e avessero capito quello che stava succedendo avremmo passato un bel guaio!». «Un’altra volta, invece», continua il nostro, «mi sono messo a recitare la Canzone di Legnano del Carducci, calcando il tono su alcuni versi che dicono: “La primavera in fior mena tedeschi pur come d’uso. Fanno Pasqua i lurchi ne le lor tane, e poi calano a valle”».
«Oggi può sembrare poca cosa, ma allora, per noi lassù, queste cose erano importantissime, ci hanno permesso di sopravvivere…», cerca di farci capire l’ex internato. «I nostri non erano dei campi di eliminazione, e questo deve essere ben chiaro: noi militari italiani, a differenza degli ebrei, non siamo stati sterminati dai nazisti. E tuttavia la nostra prigionia è stata davvero dura… La fame soprattutto. Lei che siede davanti a me», ci dice Tedeschi con crescente passione, «può forse immaginare cosa sia l’aver fame per due giorni. Ma nessuno può veramente comprendere cosa voglia dire essere attanagliati dalla fame per due anni, se non chi l’ha provato!». «Ne abbiamo lasciati tanti lassù a Wietzendor…», bisbiglia infine in un sussurro, percorso da un brivido di commozione.
Gianrico Tedeschi potè rientrare a casa il 5 settembre del 1945. «I miei genitori erano sfollati da Milano per paura dei bombardamenti aerei e c’era tutto da ricostruire», racconta. «Subito ho preso contatto con Giorgio Strehler, che immediatamente dopo la guerra aveva fondato uno studio d’arte drammatica che sarebbe stata la premessa per il futuro Piccolo Teatro. Ma io ero impaziente e all’epoca la piazza più importante per chi voleva recitare era Roma, dove c’era la grande Accademia di Stato, quella diretta da Susi d’Amico, che vantava insegnanti come Sergio Tofano e registi come Orazio Costa Giovangigli. Così sono andato nella capitale, e credo di avere fatto la scelta giusta».
C’è qualcosa, chiediamo al maestro congedandoci, che ritorna ancor oggi nei suoi spettacoli dell’esperienza dei lager? «Molto e spesso», ci confida Tedeschi. «Nei prossimi giorni, ad esempio, porterò in scena il Ruzante, che può essere letto come un inno contro la guerra. Contro tutte le guerre».




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie