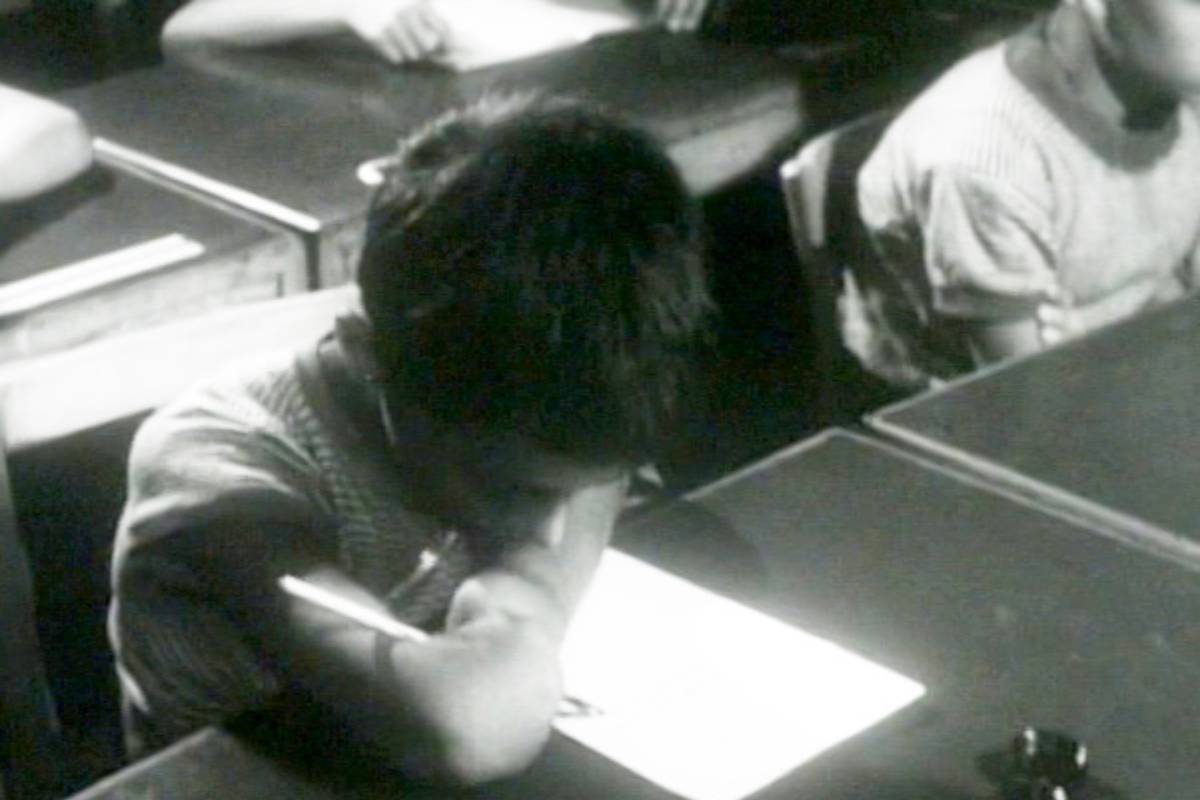La celebre lirica del grande poeta di Recanati ha compiuto 200 anni. Ma la sua bellezza e la sua profondità è ancor oggi intatta.

di Oliviero
GIULIANI
L’infinito, una delle liriche più brillanti della letteratura italiana, conosciuta in quasi tutte le lingue del mondo, ha da poco compiuto duecento anni dalla creazione del suo autore, Giacomo Leopardi (1798 – 1837). Due secoli sono uno spazio storico ben definito, a dispetto dei temi – lo spazio e il tempo – entità indefinite e sfuggenti che intrecciano il tessuto di questo idillio.
Appreso sui banchi di scuola da generazioni di studenti, questo carme ha la capacità di squarciare orizzonti immensi, accendere interrogativi radicali, suscitare emozioni sempre nuove, particolarmente, ma non solo, nell’età dell’adolescenza. Il poeta eleva la sua elegia sull’«ermo colle», l’altura solitaria nei pressi di Recanati che viene abitualmente identificata con il monte Tabor. Anche Leopardi è uno spirito solitario e inquieto. Siede a pensare a ridosso di una siepe la quale parrebbe impedire lo sguardo che pure protende verso spazi sconfinati e ha forza di penetrare silenzi sovrumani, in un universo misterioso e senza limiti. Perfino il vento, che muove con levità le foglie e le frasche delle piante attorno, ha un’assonanza con la voce che perviene dalla profondità dell’immenso ed evoca l’eternità, la quale avvolge le stagioni dell’uomo, quelle passate ed estinte, e quella di adesso.
Figlio del suo tempo
Leopardi, ammiratore del mondo classico e, in seguito, esponente qualificato del romanticismo, è stato un testimone eccellente del suo tempo, l’Ottocento, anche se con tratti di profonda originalità. Nobile di provincia – il padre Monaldo era conte, la madre Adelaide Antici marchesa – crebbe in ambiente aristocratico improntato a un cristianesimo sostanzialmente formalista: la mamma era una donna devota ma non sempre illuminata nelle proposte religiose, il fanciullo aveva tre precettori, di cui uno gesuita. Divenendo adulto, Giacomo avvertiva un senso di superiorità nei confronti del popolo rurale, sentiva di doversi distinguere dalla plebe. E tuttavia lo coglieva sempre più l’insofferenza per il divario tra l’ideale della bellezza, che lo affascinava, rispetto ai difetti fisici del corpo che lo imbarazzavano e lo conducevano a un certo isolamento, a fuggire la realtà.
Ancora giovanissimo si chiudeva in uno studio intenso, ossessivo, quasi fuori del mondo; aveva un talento eccezionale, una facilità creativa per l’arte poetica e la scelta delle parole. In lui era costante l’anelito della ricerca che ne rimarcava la gravità, anche perché si sentiva come condannato all’infelicità. Sentiva crollare il mito della ragione che, secondo i parametri dell’epoca, avrebbe avuto il compito di distruggere la barbarie e ricomporre l’unità dell’uomo con la natura.
Ma in tal maniera si infrangono anche le illusioni che renderebbero desiderabile la vita; tutte, meno una, l’amore, che pure ha sentore che gli venga negato ma che tuttavia non smette mai di ricercare. Indubbiamente è l’aspetto fisico a fargli credere di non essere amato. Così la sua infelicità diventa l’emblema dell’infelicità universale, il parametro del dolore cosmico.
Il giovane Leopardi e il cristianesimo
Come sopra rilevato, nella sua infanzia Leopardi aveva conosciuto in famiglia un cristianesimo formalista, poco autentico. Eppure la religione veniva considerata dal poeta di Recanati in maniera positiva in quanto aiuta l’uomo a superare l’angoscia esistenziale, rinnovando le illusioni del tempo antico. Come se al mito pagano si sostituisse la saga cristiana. Ma il giovane pensatore non poteva trovarvi un autentico senso della vita. È vero però che quando canta l’amore, il vate sognatore usa un linguaggio «religioso», alto, quasi indicibile. Egli aspira a qualcosa di sublime perché si sente prigioniero del mondo. Ecco allora il sogno: «Forse s’avess’io l’ale / (…) più felice sarei» (Dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia). È la nostalgia del volo, la brama delle altezze.
Eppure Giacomo confessa al padre di non essere mai stato irreligioso, anche se sente sempre il problema della vita futura. Come il Giobbe della bibbia anche Leopardi è fortemente provato dalla vita, è insidiato dal tedio della quotidianità, avverte la natura come matrigna. Ma Giobbe attraversa il dolore, prende coscienza dei propri limiti di creatura e sperimenta il bisogno di Dio a cui si affida. E ritrova la fiducia nell’Altissimo.
Il poeta-filosofo di Recanati è invece troppo avviluppato dal razionalismo e stenta a ricorrere con fiducia alla fede, troppo invischiato dallo scetticismo e dal materialismo dominanti nel suo tempo.
Credente o non credente?
Il poeta-sognatore è comunque preso dallo stupore dalla grandezza e dall’estensione dei suoi desideri. Avverte con forza il fascino della perfezione. In ciò non mancano segnali che fanno percepire l’artista non troppo lontano da Dio, particolarmente quando è alle prese con tematiche – come il problema del male – delle quali la ragione non riesce a dare spiegazione. Anche il fascino della donna è da lui avvertita come presenza del divino, un segno che rimanda oltre, una traccia di qualcosa immensamente più grande. Esistono inoltre delle costanti nella sua visione lirica: lo sguardo verso il cielo stellato, un clima di attesa, una speranza ostinata.
Per Leopardi appare sfuggente la definizione di credente o non credente: sicuramente è stato un uomo inquieto, che ha vissuto in sé stesso, nel suo corpo, l’inganno di una natura da cui si sentiva come raggirato, una creatura dilaniata da aspirazioni impetuose e seducenti come la bellezza, l’infinito, l’amore, e che dunque non ha mai smesso di ricercare il senso della vita. Un uomo che bramava di volare alto, ma gli sono mancate le ali.
Una creatura dalla struggente nostalgia di Dio. Una personalità che comunque ci tocca profondamente.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie