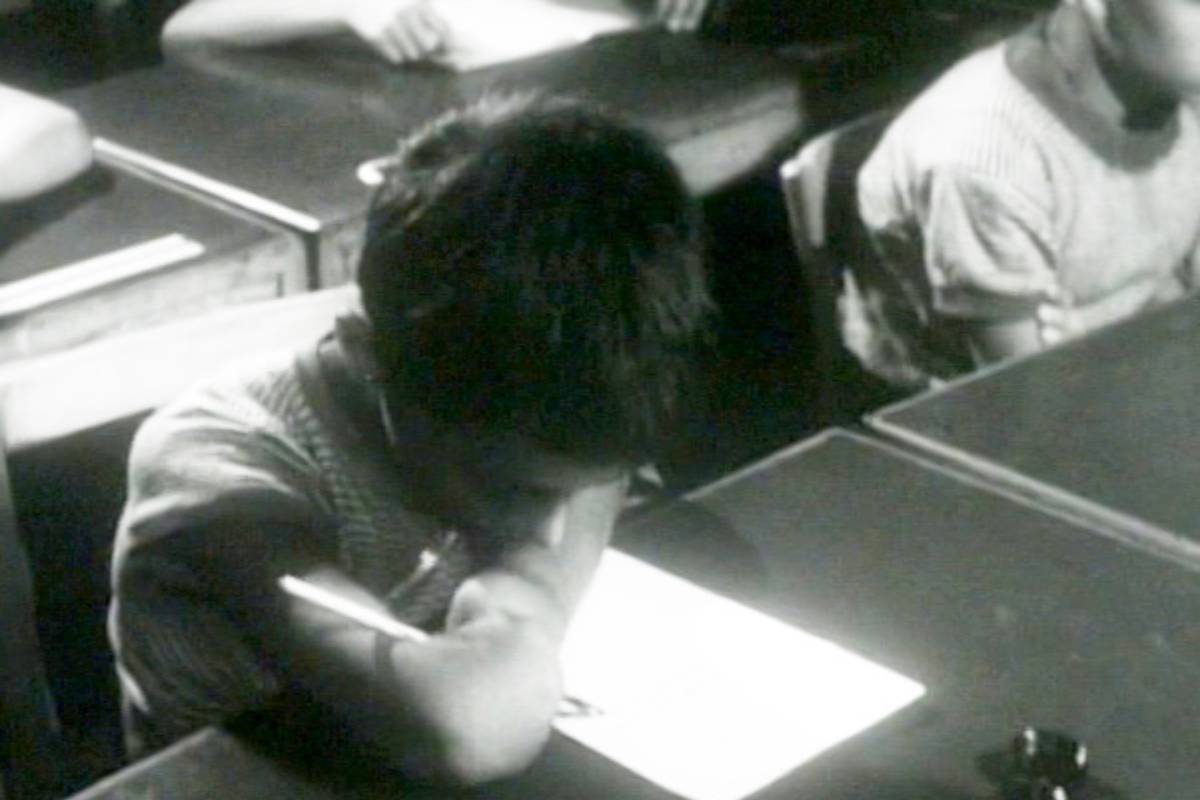I discorsi dell'allora arcivescovo di Milano alla Fiera e sulla Fiera di Milano sono la prova non solo della sua tensione evangelizzatrice nei confronti della modernità, ma anche della sua volontà di intessere un rapporto di autentico dialogo con la vivace e produttiva società milanese negli anni del cosiddetto “boom” economico.

Mons. Marco
Navoni
Dottore Biblioteca Ambrosiana
Nominato arcivescovo di Milano il 1° novembre 1954, Giovanni Battista Montini fece il suo ingresso in diocesi il 6 gennaio dell’anno successivo: catapultato dagli ovattati ambienti della Segreteria di Stato nel fervore del mondo milanese (o – come ebbe a dire efficacemente l’amico Giulio Bevilacqua, poi cardinale – catapultato «dalla diplomazia alla brutalità»), trovò una città in piena trasformazione. Per usare immagini care al compianto professor Giorgio Rumi, Montini trovò una società che si stava profondamente trasformando: ai campanili delle chiese andavano sostituendosi le ciminiere degli stabilimenti e al suono delle campane le sirene delle fabbriche. E l’arcivescovo intuì immediatamente che in prospettiva il problema che la Chiesa avrebbe dovuto affrontare nell’immediato futuro sarebbe stato quello di una progressiva “secolarizzazione” (anche se il termine non compare negli scritti montiniani), con lo scollamento, se non la reciproca estraneità, tra un mondo del lavoro sempre più evoluto e la dimensione religiosa della vita.
A questo tema Montini dedicò numerosi interventi e la sua presenza nelle fabbriche sta a testimoniare la sua volontà di essere – secondo l’augurio che gli rivolse mons. Angelo Dell’Acqua, suo collega alla Segreteria di Stato, nel momento in cui lasciava Roma per Milano – l’“arcivescovo dei lavoratori”. E tuttavia, dell’effervescente mondo milanese tra fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta del secolo scorso, con tutti i suoi complessi problemi, il fenomeno Fiera di Milano fu senz’altro quello che colpì in maniera singolare l’arcivescovo Montini: a tal punto che a partire dal 1956 fino al 1963, a pochi mesi dalla sua elezione a vescovo di Roma, ogni anno volle essere presente tra i padiglioni della Fiera; ma non solo: praticamente ogni anno invitò gli espositori a partecipare a una celebrazione eucaristica loro riservata, nelle principali basiliche della città, a cominciare dal Duomo. E la risposta libera degli operatori economici non deluse mai l’arcivescovo, che tenne per loro discorsi molto elaborati e ricchi di proposte e riflessioni. Se la maggior parte degli interventi di Montini sono dunque omelie, ci restano anche due importanti discorsi tenuti l’uno presso la Biblioteca Ambrosiana (nel 1956) dove aveva invitato non solo gli espositori, ma anche la dirigenza della Fiera; e l’altro tra i padiglioni della Fiera stessa, nel 1960, per l’inaugurazione della statua di sant’Ambrogio, patrono di Milano.
Di fatto Montini restò profondamente colpito da quello che lui stesso ebbe a definire il «mondo incantato» della Fiera Campionaria: un luogo dove la tecnologia, la scienza, lo studio, la progettualità umana, il lavoro intervengono sulle cose, spesso inerti e ostili, per renderle utili, servibili, capaci di soddisfare le necessità dell’uomo. Un luogo – la Fiera – dove andò realizzandosi l’incontro del “genio italiano” con quello di altri popoli, dove l’incontro può trasformarsi così in conoscenza reciproca, in confronto, in onesta emulazione. L’arcivescovo aveva intuito che la Fiera non è solo luogo di scambi, ma può e deve diventare anche luogo di cultura; e celebre, a tal proposito, resta questa sua affermazione: «intorno all’agorà si allunga la polis, intorno al mercato si sviluppa la città; la vita commerciale dà incremento alla vita civile e alla vita politica».
Di fatto sono molteplici e cangianti le sfumature di contenuti reperibili nel complesso dei discorsi di Montini per la Fiera di Milano. Innanzitutto dobbiamo registrare un sincero entusiasmo e apprezzamento per le conquiste della tecnologia, grazie a una visione sostanzialmente positiva sul mondo del lavoro e sul progresso; ma accanto a questo apprezzamento affiora spesso, soprattutto nelle omelie, la cautela, la messa in guardia davanti all’illusione sempre in agguato nel cuore dell’uomo di potersi costruire da sé un paradiso di felicità terrena. L’arcivescovo aveva infatti intuito come nel progresso sia per così dire insito un limite che più che risolvere può talvolta creare nuovi e impensati problemi; e nel 1961 ebbe a chiedersi e a chiedere ai suoi interlocutori, con un incalzare di domande: «E tutto questo progresso a che cosa servirà? alla felicità dell’uomo o alla sua noia e alla sua disperazione? alla sua libertà o alla sua schiavitù? alla pace o alla guerra? alla salvezza dell’uomo o alla sua rovina? Che sarà il frutto finale di tanta fatica? il pianto o la gioia? la morte o la vita?». Sollevare nella mente dei suoi ascoltatori questi dubbi, o meglio queste domande di fondo (o di senso), era appunto una messa in guardia, un avvertimento saggio e realistico a non lasciarsi incantare dalla quella che lui stesso aveva definito «scena abbagliante e incantatrice» del progresso umano. Ma nel contempo la sua era quasi una “profezia”, un “presentimento”, che nel cosiddetto progresso, se incontrollato e insipiente, potevano annidarsi le condizioni di un futuro di disperazione, di schiavitù e di morte.
Numerosi, in questi discorsi sono inoltre i richiami alla dimensione sociale che ogni forma di profitto e di ricchezza deve contemplare nell’orizzonte imprescindibile della carità cristiana, secondo l’insegnamento tradizionale della dottrina sociale della Chiesa. Ma ciò poteva essere abbastanza scontato sulle labbra di un vescovo. Quello che invece risulta essere il tema forse più originale, e che praticamente è reperibile in quasi tutti i suoi interventi alla e sulla Fiera di Milano, è il seguente: la possibilità, anzi la doverosità, di “trascendere” la pura dimensione sociale ed economica di cui la Fiera era indiscusso emblema, per risalire alla dimensione spirituale dei principi e dei valori eterni. Basti citare, a questo proposito, quanto ebbe a dire nell’omelia del 1959: se la scienza è la capacità di «decifrare certe leggi nascoste nel seno profondo delle cose», estraendone magnifici effetti, se è la capacità di scoprire e impiegare «qualche aspetto del pensiero sepolto nel creato», allora bisogna riconoscere che nel lavoro umano opera lo “spirito” che studia, che scopre, che domina la materia, che rende esplicito un ordine implicito, in una parola: «che obbliga l’uomo a diventare collaboratore con Chi, primo e sommo, ha creato il tutto». Nella favolosa esposizione, nell’immenso e meraviglioso mercato che è la Fiera si vedono i prodotti più avanzati del lavoro e del progresso: ebbene – conclude Montini, rivolgendosi direttamente agli operatori –: «Quanto più le cose, le vostre cose, sono evolute e perfette, tanto più risentono della presenza e della potenza dello spirito».
Complessivamente i discorsi di Montini alla Fiera e sulla Fiera di Milano sono la prova non solo della tensione evangelizzatrice da parte dell’arcivescovo nei confronti della modernità, ma anche della sua volontà di intessere un rapporto di autentico e schietto dialogo con la vivace e produttiva società milanese negli anni del cosiddetto “boom” economico. E tali discorsi rivelano che in questo dialogo egli elesse gli operatori della Fiera a suoi interlocutori privilegiati: infatti – come è stato giustamente osservato da quella che è senz’altro la più acuta studiosa e interprete dell’opera e degli scritti di Montini arcivescovo (oltre che di Montini papa), la prof.ssa Giselda Adornato – gli operatori della Fiera non si identificano semplicemente con gli imprenditori, ma sono coloro che attraverso l’intelligenza, lo studio delle leggi della natura e della fisica, con l’abilità tecnologica e l’inventiva, con la ricerca continua della perfezione, in una parola con un autentico processo “culturale”, trasformano le cose da inutili a utili per l’uomo, promuovendo così un autentico progresso, aperto ai valori superiori. E tutto questo con la prospettiva ovvia per la strategia pastorale di un vescovo, di ricostruire un rinnovato e positivo rapporto tra il mondo del lavoro e dell’imprenditoria da una parte e la dimensione religiosa dall’altra.
Che la ricostruzione di questo rapporto, così tenacemente auspicato da Montini negli anni del suo episcopato, si sia di fatto realizzata non è possibile dirlo; anzi lo iato tra religione e modernità, con il passare dei decenni, sembra essersi ulteriormente allargato. E tuttavia l’aver richiamato con forza e in molteplici modi la necessità e l’urgenza di trovare una soluzione plausibile e percorribile al nodo di un tale ricorrente problema è senz’altro l’indicazione che Giovanni Battista Montini ha trasmesso come valida e attuale anche per il nostro presente.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie