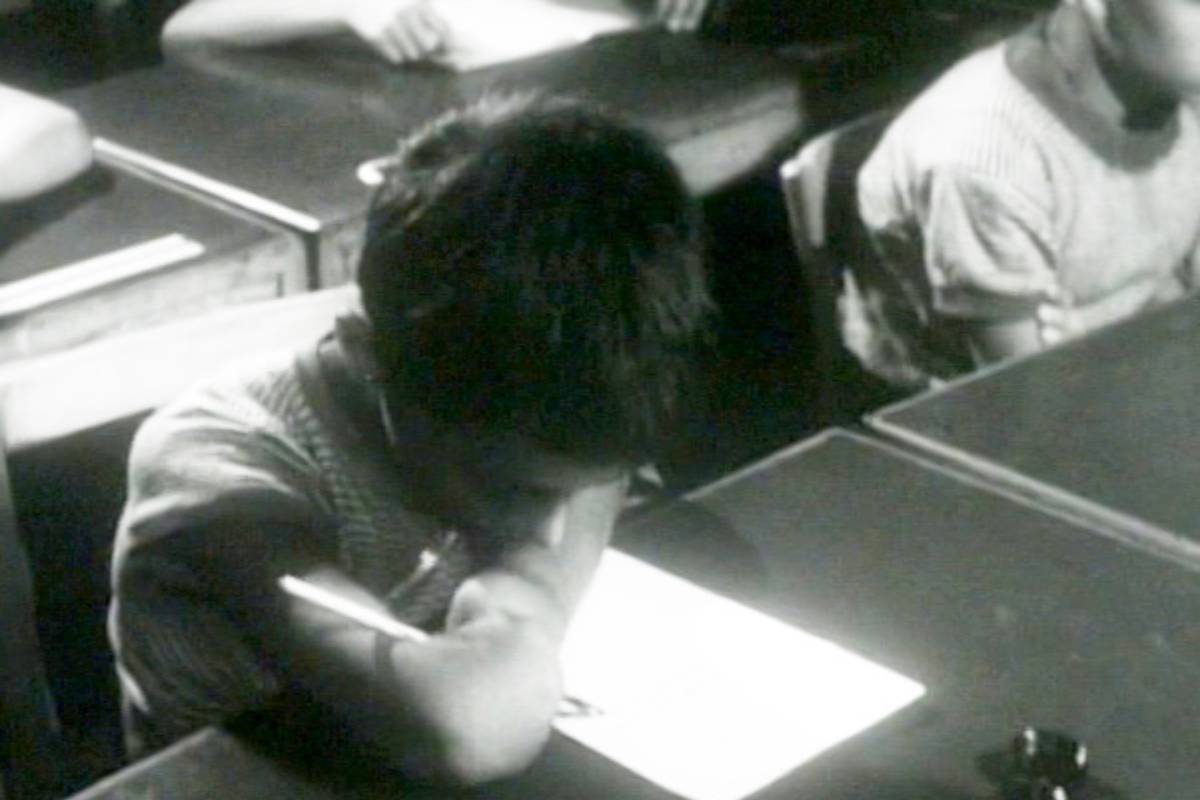Al Centro diocesano di Milano presentazione del libro di Luisa Bove basato sulle lettere del padre Gino, militare della Divisione Acqui, inserite sul più vasto sfondo bellico di quegli anni. Ecco un ampio stralcio della prefazione di Giorgio Vecchio.
di Giorgio VECCHIO
Storico dell’Università di Parma

Proprio nei giorni in cui si ricorda l’eccidio di Cefalonia (settembre 1943) in cui persero la vita 7 mila militari italiani della divisione Acqui, esce in libreria il volume Il giorno in cui mio padre non morì di Luisa Bove (In dialogo, 232 pagine, 16.90 euro). Pubblichiamo un ampio stralcio della prefazione dello storico Giorgio Vecchio
C’è una notizia, in questo libro, che mi ha molto colpito e voglio sottolinearla subito. Estate 1945: nel campo di Sluck, in Bielorussia, si ritrovano numerosi militari italiani deportati dai nazisti dopo lo sfascio del Regio Esercito l’8 settembre 1943 e ora nelle mani dei vittoriosi sovietici, in attesa del rimpatrio. Tra loro c’è Gino Bove, il padre dell’autrice di queste pagine. Con i suoi compagni di sventura egli mette in piedi un’associazione di Azione cattolica, della quale custodirà gelosamente la lista degli aderenti […]. Sapevo di tanti gruppi informali di preghiera, di recita del Rosario o di lettura dei Vangeli nei Lager destinati ai nostri Internati Militari, ma questa è decisamente la prima volta che mi capita di leggere della volontà di costituire una vera e propria associazione, inevitabilmente provvisoria e altrettanto inevitabilmente dal carattere nazionale e non parrocchiale.
L’episodio è per forza di cose collocato al termine delle peripezie militari di Bove, ma può essere considerato illuminante anche retrospettivamente, per il motivo che la solidità di una fede vissuta, senza superstizioni e senza esibizioni, traspare in tutti i comportamenti del giovane soldato. Di questa fede semplice e tuttavia consapevole e robusta troviamo tante indicazioni nelle lettere che Gino scrive a casa, da Cefalonia e poi dai campi di prigionia. Si vede bene che, per la sua generazione di cristiani, la fede è ancora una forza capace di scandire con naturalezza le tappe della vita e anche le più modeste successioni dei giorni del calendario.
E qui tocchiamo con mano il contributo più prezioso di queste pagine: la nostra autrice ha costruito il suo libro su una documentazione di prima mano, quella costituita anzitutto dalle tante lettere conservate con affetto in famiglia. Lettere, sottolineo, e non ricordi diretti. Infatti l’esperienza di Bove è simile a quella di tanti altri nostri protagonisti della II guerra mondiale: poca voglia di parlare e di raccontare negli anni successivi, quasi a voler tenersi dentro tutto nel cuore. Paura di spaventare i figli? Voglia di rimuovere? Timore di non essere creduto? Desiderio di non gonfiare orgogliosamente il petto? Senso di colpa per essere sopravvissuto, mentre tanti compagni sono stati travolti dal gorgo della guerra? Non sappiamo cosa abbia pensato tra sé e sé Gino: di certo, questi dubbi hanno in vario modo attraversato la mente di tanti, fossero essi ex combattenti o ex partigiani, ex prigionieri militari o ex deportati per motivi politici o razziali. […]
Ho già accennato alla fede semplice di Gino, che possiamo, per così dire, toccare con mano. Ma che dire delle notizie di prima mano che egli ci offre sulla eterna capacità italiana di arrangiarsi da soli, in un contesto fatto di disorganizzazione e di carenze? È impagabile l’istantanea di Bove che scrive alla sorella perché compri lei le stellette da cucire sulle divise e, addirittura, faccia comporre il timbro da usare per i documenti firmati dal comandante della sua batteria. Così come fa sorridere la richiesta di comprare – allora, poi! – un gran numero di calze da donna, da usare come merce di scambio con la popolazione locale e avere in cambio qualcosa di meglio da mangiare. […]
Luisa Bove ci racconta tutto quel che è riuscita a recuperare sulla vita militare di suo padre con un doppio sforzo che merita di essere segnalato. Da una parte, infatti, si è sforzata di far incontrare le testimonianze con la storiografia, in modo da non perdere mai di vista il contesto più ampio; dall’altra, ha steso in tutte le pagine di questo libro una dolce pietas filiale che non guasta, perché sempre trattenuta e controllata, mai fastidiosa. È in questa duplice prospettiva che si possono apprezzare meglio le sue considerazioni sul silenzio che per tanto, troppo, tempo è stato fatto calare sulla tragedia della divisione Acqui, fino al tardivo, ma irreversibile, recupero di una memoria condivisa.
Quanto detto può servire come risposta a una possibile obiezione da parte di chi scorra superficialmente queste pagine. Obiezione riassumibile in una sola parola: “basta!”. Basta con la continua pubblicazione di diari, lettere e testimonianze sulle due guerre mondiali! Sappiamo già tutto! Lo sfogo è comprensibile, ma non ha motivo di essere: ogni testimonianza che aggiungiamo nella nostra biblioteca ci arricchisce un po’ di più, ci costringe almeno per un attimo a pensare alle sofferenze di uomini e di donne, a confrontarci con il problema del male e della violenza, della guerra. O, nel caso, di Gino, anche a meditare sul rapporto tra la vita quotidiana e la fede.
Del resto è un po’ anche per questi motivi che nel 2015 il Premio Nobel per la letteratura è stato attribuito a Svetlana Aleksievic, da decenni impegnata a ridare spessore ai “dimenticati” della guerra, nel suo caso alle donne sovietiche. Si legga, per averne una riprova, il potente affresco collettivo da lei tracciato in La guerra non ha volto di donna. Luisa Bove non ha ambizioni da Nobel, penso. Ma questo suo libro va nella stessa direzione, seppure con un protagonista diverso: un giovane italiano, mezzo napoletano e mezzo milanese, quasi a sintetizzare anche in questo modo il dramma di una nazione intera.






 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie