Accompagnare i malati alla morte evitando l'accanimento terapeutico. Intervista all'endocrinologo Alberto Cozzi in vista del convegno a cui l'Arcivescovo tiene una “lectio magistralis”
di Annamaria
Braccini
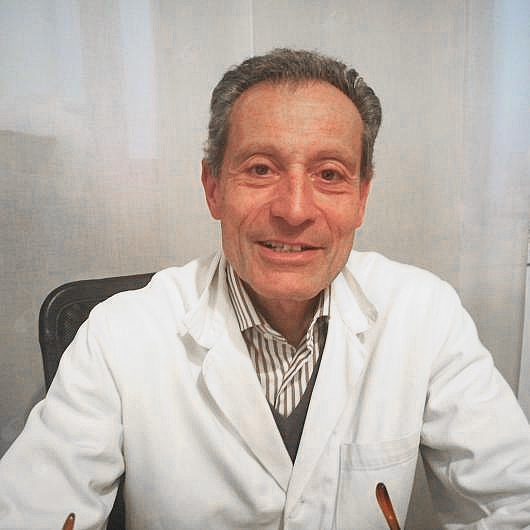
Un convegno importante, di alto profilo scientifico, che vedrà anche la presenza e la lectio magistralis dell’arcivescovo, mons. Mario Delpini, per riflettere a più voci sul «Fine vita», nella Giornata nazionale Fadoi dedicata a questo delicato tema. Questione complessa, trattata, a volte con superficialità, per farne, magari, una battaglia ideologica e politica. Importante, dunque, riflettervi con la voce dei clinici e di chi conosce pienamente questa materia sulla quale i medici cattolici sono «come è naturale, molto sensibili», dice Alberto Cozzi, endocrinologo e medico di base, presidente della sezione lombarda dell’Amci, l’Associazione dei medici cattolici italiani.
Come i medici cattolici si sentono coinvolti in quest’iniziativa?
La fase finale dell’esistenza sta diventando sempre più presente nella vita dei nostri fratelli: le malattie degenerative, irreversibili, che non portano a una guarigione e quelle croniche stanno diventando la parte preponderante del nostro lavoro. Assieme a questo, la capacità della medicina di esprimersi in modo potente dal punto di vista tecnologico ha fatto sì che, naturalmente, la vita media avanzi e la sopravvivenza vada molto in là negli anni, con la presenza di tanti grandi anziani e con patologie con cui fare i conti in termini drammatici, quelli della sofferenza globale – che non è solo dolore – della persona. Il “fine vita” è, dunque, anche un problema di accompagnamento umano che ci coinvolge come medici e come cristiani.
Cosa significa sofferenza globale?
È una sofferenza relazionale, perché implica le relazioni amicali, parentali e tutto l’universo che sta intorno al malato. Come medici cattolici riteniamo che occorra prendere consapevolezza e stare vicino ai nostri malati fino in fondo, accompagnandoli in questo cammino con competenza, con tecnica, anticipando il più possibile il ricorso alle cure palliative e con tutte le risorse possibili. Ma altrettanto necessario è quello che definirei il “non abbandono”, con quella che il Papa ha definito una “prossimità responsabile”.
Nel mondo contemporaneo, spesso si tende a negare la morte e ci si crede immortali, oppure si fa delle questioni del fine vita una polemica ideologica e di parte, basti pensare al cosiddetto suicidio assistito…
In questo contesto è fondamentale uscire dalle ideologie di tutti i generi, quelle laiche e anche quelle cattoliche, magari ferme a una vecchia accezione con la quale eravamo abituati a ragionare. Si tratta, invece, di pensare alla morte in termini di dignità. Vivere vuol dire compiere un cammino che comporta anche il limite. Il momento della morte va vissuto con dignità, che significa non arrivare a ideologizzarlo o a prolungare la vita con ogni mezzo quando non c’è una speranza di guarigione o di una esistenza, appunto, di buona qualità e dignitosa. No, quindi, all’accanimento terapeutico. Dare scacco alla morte è sempre stato il desiderio del medico, magari talvolta, con un certo delirio di onnipotenza. Chiediamoci, invece, a quale morte dobbiamo accompagnare? Ritengo che la risposta sia, appunto, la dignità. Una morte con dignità vuol dire avere un sostegno, un accompagnamento umano, una buona relazione non contrattualistica col medico.
È la relazione di cura che qualifica l’intervento medico e specialistico?
La relazione di cura è un prendere atto che la libertà della persona è una libertà relazionale, non un libero arbitrio che fa dire: “Faccio quello che voglio della mia vita”. Nel rispetto massimo della vicenda di ciascuno, credo che il medico oggi, quello credente a maggior ragione, debba rispettare pienamente quella che è una decisione personale che, tuttavia, ha un suo confine e può essere un’autodeterminazione. È, invece, una libertà da coltivare nella responsabilità e nella relazione da coniugare e da declinare nel tempo.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie











