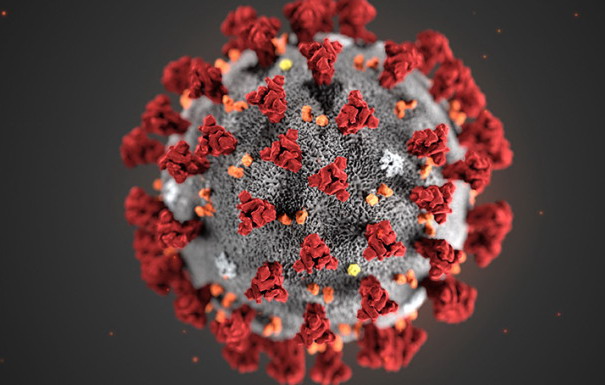Dagli Stati Uniti all’Italia, dal XIV emendamento all’articolo 3 della Costituzione
di Gianfranco
GARANCINI

Ci voleva un tipo “originale” come Donald Trump per tirar fuori dal mazzo la briscola (“trump” vuol dire, appunto, “briscola”) dell’abolizione del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. Il XIV emendamento, ratificato nel 1868 (centocinquantuno anni fa) insieme con il XIII e il XV, fa parte dei cosiddetti “emendamenti della Ricostruzione”, dopo la fine della guerra civile fra Nord e Sud. Se il XIII stabilisce l’abolizione della schiavitù e il XV proibisce limitazioni al diritto di voto in ragione della razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù, il XIV emendamento riguarda vari temi, suddivisi nelle sue cinque sezioni: giusto processo, uguale protezione delle leggi, rappresentanza degli Stati e garanzia del diritto di voto, condizione giuridica del debito pubblico; ma la disposizione più importante e storicamente più rilevante per il futuro degli Stati Uniti è quella contenuta nella prima frase della prima sezione: «Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, e sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono». Basta essere nato, anche casualmente, sul suolo degli Stati Uniti, per acquistarne, per questo solo fatto, la cittadinanza e per conservarla vita natural durante (a meno di rinuncia espressa), anche se si acquista la cittadinanza di un altro Paese (ne sanno qualcosa gli Italiani con doppia nazionalità, anche casuale, alle prese con l’applicazione della normativa Fatca, in tema di doppia imposizione fiscale: e l’Irs – l’agenzia delle entrate americana – è inesorabile e raggiunge tutti…).
Quelle poche righe del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America sono state – almeno dal punto di vista giuridico – uno dei fondamentali fattori di sviluppo economico, sociale, altresì culturale degli Usa, attraverso quel crogiolo (“melting pot”) di razze, lingue, esperienze, culture che sono diventati in questi centocinquant’anni dall’approvazione del XIV emendamento.
Ciò non è avvenuto senza difficoltà: basti pensare che molti Stati lo hanno ratificato subito, tra il 1867 e il 1870, ma poi hanno ritirato la ratifica originaria per ripetere la ratifica molto più tardi, e dopo dure polemiche giuridiche che hanno visti protagonisti prevalentemente i giudici delle Corti supreme dei singoli Stati (che sono di nomina politica, però). Gli ultimi in ordine di tempo sono stati New Jersey e Ohio che sono arrivati nel 2003.
In effetti – ma forse Donald Trump non lo sapeva, e nessuno gliel’aveva detto – il procedimento per l’approvazione di un emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti è complesso e lungo, così come è complesso e lungo – nel rispetto dell’antico principio del contrarius actus – il procedimento per la sua cancellazione: è necessario un altro emendamento uguale e contrario, approvato almeno dai due terzi sia del Senato sia della Camera dei Rappresentanti, nonché dai due terzi delle assemblee legislative dei singoli Stati; l’emendamento così approvato dovrà essere ratificato entro sette anni dalla sua approvazione dalle assemblee legislative di almeno tre quarti degli Stati. Pur a prescindere dalle ragioni politiche, culturali, sociali, economiche che militano decisamente contro la cancellazione del principio contenuto nel XIV emendamento, al fantasioso Trump non basterebbero le maggioranze parlamentari (per altro alquanto precarie) di cui fruisce ora, né altresì gli anni di presidenza che anche nella più rosea (per lui) delle previsioni gli resterebbero da fare, per dar corpo alla sua pretesa consegnata una mattina a un ennesimo dei suoi soliti, temutissimi (soprattutto dai suoi collaboratori) tweet del tutto estemporanei, il più delle volte scritti e subito dimenticati (ma dopo aver creato, di solito, inenarrabili sconquassi negli Usa e, più o meno, ovunque nel mondo). Questa trovata, però, non è un capriccio: è il tentativo, rozzo e sfacciato quanto si vuole ma proveniente dall’uomo più potente del mondo, di penalizzare in un altro modo gli immigrati – soprattutto hispano-americani – che costituiscono ormai una notevole e indispensabile percentuale del popolo americano, complessivamente inteso (con gli italiani, i tedeschi, gli svedesi, gli irlandesi, i cinesi, gli asiatici del sub-continente, e così via, senza dimenticare i discendenti degli schiavi “importati” dall’Africa e dal Centroamerica; i nativi americani sono, invece, stati ridotti ad una piccolissima minoranza).
E in Italia? Qual è lo stato di salute dello ius soli? Nulla sembrerebbe cambiato da quando, giusto due anni fa, ne parlammo su queste stesse pagine dell’osservatorio, in occasione della discussione in Senato d’un disegno di legge che poi – come capita a molti Ddl da noi, soprattutto a quelli che riguardano significative riforme – si è perduto nelle nebbie delle stanze del Parlamento: non solo di ius soli (all’americana o, più vicino a noi, secondo il diritto romano) non si parla più, e continua ad aver vigore il più stretto ius sanguinis (sei cittadino italiano solo se lo sono i tuoi genitori), ma le condizioni per ottenere, pur avendone diritto e pur essendo nati in Italia, la cittadinanza italiana sono state di recente inasprite, e aggravate con il decreto legge numero 113 del 2018 (legge numero 132 del 2018), il primo cosiddetto “decreto Salvini”, che con l’articolo 14 ha modificato la già rigida legge sulla cittadinanza del 1992 (governo Andreotti VII, ministro dell’interno Vincenzo Scotti) aggravando la pretesa di presupposti giudiziari, linguistici, burocratici, e portando a 48 mesi (quattro anni!), dalla data di presentazione della domanda il termine di definizione dei procedimenti burocratici (chi, avendone pienamente diritto, fa domanda a 18 anni, appena diventato maggiorenne, avrà la risposta quando ne avrà 22: e, ovviamente, la risposta potrebbe essere negativa…).
E questo, purtroppo, penalizza quei giovani (ormai circa un milione) che – nati in Italia, dopo aver frequentato le scuole italiane, lavorando e pagando le tasse in Italia, e così via – non sono però riconosciuti come cittadini italiani. Salvo…
Salvo quando servono. Quando nel mondo (sport, spettacolo, lavoro, arte, impresa…) hanno successo con la maglia o la “marca” italiana, e suona l’inno di Mameli, e prendono medaglie e riconoscimenti nel nome dell’Italia, nessuno si scandalizza, o grida alla contaminazione della razza (!?), se hanno la pelle nera, o caffelatte, o color oliva, o gli occhi a mandorla: quando vincono e producono, e rendono, vanno tutti bene. È quando chiedono che vengano rispettati e praticati i loro diritti pubblici fondamentali di persone (primo fra tutti, perché di tutti condizione giuridica, la cittadinanza) che la “mano pubblica” si inventa ostacoli e difficoltà, e rallenta, e in pratica frena fin quasi a fermare ogni meccanismo.
Eppure nella nostra Costituzione non c’è solo un emendamento, ma un articolo intero: l’articolo 3 (ndr Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali). Che troppi nostri legislatori e governanti, come l’allegro Donald, non dico vorrebbero cancellare, ma tante (troppe) volte tendono a dimenticare, quando fa comodo per fare un bel comizio, o quando ci si vuole aggregare al codazzo dei “sovranisti”.




 Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie
Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie